Nella sua monografia su William Congdon, Morasso confessa di essere stato «colpito nel vivo», dalla rara capacità di questo pittore di persistere, con la mente, «nel fuoco del proprio rovello conoscitivo» (Essere trasfigurato, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano, BI, 2012, p. 17) – quella ’”ossessione” – quasi una “monomania” – che in Congdon ha per oggetto la figura della croce, e in Morasso, ora il Crocifisso, ora il volto del Cristo riprodotto sul sacro Mandylion, che nelle Indie di Genova forma il polo attrattivo-repulsivo del “gironzolare” dell’io narrante/flâneur. L’oggetto amato è anche l’oggetto temuto, e temuto non solo in ragione di quella naturale ripugnanza suscitata dal sacro, la quale si intreccia, in una strana forma di contrastante armonia, con il sentimento opposto di attrazione, ma anche perché, nell’Obbedienza, l’oggetto con cui l’osservatore malinconico sceglie di misurarsi, in un vis-à-vis drammatico e senza scampo, non è più il volto, sia pure inquietante, del sacro Mandylion, ma una Crocifissione, per l’esattezza, «la più straziante crocifissione che la storia della pittura ricordi» (p. 28), in cui si rappresenta, senza eufemismi, nientemeno che «la tortura del divino in atto» (p. 18). Il dipinto, che fa parte di un più ampio complesso – la pala dell’altare di Issenheim a Colmar, capolavoro del pittore tedesco Matthias Grünewald – raffigura un Cristo spaventoso, di cui Morasso ci rende una descrizione che ha quasi l’altezza di una testimonianza. E questa scena che «affonda nel terribile e ha l’apparenza di un incubo silenzioso», questo «macello di Dio in un corpo d’uomo», è solo il primo atto di un dramma il cui prologo è costituito dal noto episodio di Gesù fra i Maestri della Legge (Luca 2,41-2,50), citato da Morasso all’inizio della sua opera.
Protagonista indiscusso di questo dramma è dunque Gesù: l’adolescente del Vangelo di Luca; il Cristo-uomo, martoriato, colto nella “visione eccessiva d’artista” da Grünewald; quello rinchiuso nelle segrete del Sant’Uffizio di Siviglia nella Leggenda del Grande Inquisitore, nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij; il Cristo morto che, nel sogno di Siebenkäs, il protagonista dell’omonimo romanzo di Jean Paul, proclama di fronte alle ombre dei defunti e allo stupefatto sognatore, l’inesistenza di Dio; e infine – ultimo atto – il Cristo cadavere “annientato” dalla morte del dipinto di Hans Holbein il Giovane (1521), da cui Dostoevskij fu impressionato al punto da scriverne ne L’idiota. Quattro momenti di un dramma che rappresentano anche i luoghi di un itinerario eccentrico, dove ogni tappa non costituisce il superamento di quella precedente, ma l’oggetto di una contemplazione (e di un’interrogazione) insuperabile, perché ossessiva, e destinato perciò ad essere meta di rivisitazioni (o rimuginazioni) continue da parte dell’osservatore malinconico. Inevitabilmente, la struttura testuale dell’operetta morassiana, in quanto prodotto di questi andirivieni, di questo procedere a zig zag, per successivi abbandoni e ritorni, assume la conformazione di un «macrocosmo scombinato e scaleno», a somiglianza dei romanzi di Jean Paul, in cui Morasso, non meno di Jean Paul, appunto, si attiene fedelmente «alle volute del suo pensiero così singolarmente complesso, piuttosto che alle trame e ai registri linguistici», lasciando che il suo discorso «si generi e si deformi in corso d’opera, per così dire, per vie di echi, contrappunti e distonie» (p. 25).
Il percorso è eccentrico, come già si è detto, perché in ballo non vi è semplicemente un’ipotesi da verificare e una tesi, per quanto complessa, da dimostrare, ma un’ossessione incardinata in quell’antinomia, i termini della quale – l’obbedienza da un lato, la libertà, dall’altro – sono i poli dialettici di un discorso il cui punto d’avvio, preannunciato dal passo evangelico di Luca, è costituito dal martirio del Cristo crocifisso, in cui come in altre, non meno drammatiche Crocifissioni, Grünewald «piega il suo genio trasfigurante a mostrare fin dove può condurre l’obbedienza» (p. 32): quell’obbedienza (al proprio mandato) in nome della quale il dodicenne Gesù si era sottratto alla tutela dei genitori terreni, venendo meno ai suoi doveri filiali. Un lembo della dolce fermezza di questo adolescente divino dev’essere rimasto impigliato nel sorriso con cui il Cristo di Dostoevskij ascolta in silenzio il Grande Inquisitore rinfacciargli ciò che costituisce il dono più prezioso da lui recato agli uomini: la libertà. E forse quel sorriso, quel bacio sonoro con cui Gesù accoglie le parole del suo avversario, hanno a che fare, più di quanto non si creda, con l’episodio evangelico narrato da Luca, dal quale, non per nulla, prende le mosse la riflessione morassiana, sorta di “scena primaria” le cui intermittenze si irradiano dal principio alla fine nel testo. Viene il sospetto, abilmente insinuato sub limine da Morasso, che, ascoltando il discorso dell’Inquisitore, Gesù si sia ricordato di quel lontano episodio della sua adolescenza – del doloroso stupore di suo padre, del cauto rimprovero, mitigato dalla dolcezza, delle parole materne. Come potrebbe questo Cristo, piombato senza preavviso, dall’al di là, nel mondo degli uomini a scompigliarne l’assetto, non provare indulgenza e compassione per la loro difficoltà a comprendere ciò che già ai suoi genitori terreni risultava indecifrabile? Libera decisione del cuore e obbedienza sono i termini di un’antinomia che è tale solo per la mente degli uomini: due rette parallele, coincidenti nell’infinito del nous divino, ma destinate a restare drammaticamente separate nel finito della mente umana. O a ritagliare lo scenario di una tragedia senza possibile catarsi, qualora venga a mancare il termine in grado di alimentare questa antinomia, e di giustificare, insieme, l’atto di suprema obbedienza in cui consiste il sacrificio della Croce: il Padre celeste.
È questa la prospettiva nichilistica, illuminata da Celada Ballanti nella dotta postfazione, fatta balenare da Jean Paul nel sogno di Siebenkäs, in cui un Cristo morto, disperatissimo, discende sull’altare per pronunciare «una parola letteralmente inaudita, e devastante. L’acme del nichilismo immaginato nel corpo stesso del divino» (p. 23): l’inesistenza del Padre celeste e l’inevitabile orfanezza degli uomini. Il nocciolo noumenico del dramma va rintracciato proprio qui, in questa orfanezza resa possibile dall’assenza del Padre, la quale autorizza, a sua volta, la morte irrimediabile del Figlio rappresentata con tanta crudezza nel dipinto di Holbein. Si tratta di una perdita che è seme e circonferenza di ogni altra, reductio ad nihilum e mortificazione di quel desiderio di felicità, da intendersi agostinianamente come ricerca di una vita che ignori la morte, cioè «della realtà piena della propria vita, definita dall’assenza di qualsiasi ammittere» (Hannah Arendt, Il concetto d’amore in Agostino, SE, Milano, 2001, p. 40), in poche parole, dell’eternità. Come il bonum dell’amor, anche l’eternità è un bene che non si può perdere, se non si vuole («Hoc est bonum quod non potes invitus ammittere», De libero arbitrio, I, 34), dice Agostino, il quale è forse, insieme a Meister Eckhart, il più autorevole (e silente) tra gli interlocutori di Morasso in quest’opera. Sicché l’assenza di Dio, se da un lato pone la pietra fondativa del pensiero nichilistico, dall’altro, sgombrando la strada all’ingresso della morte, finisce per estirpare ab imis ogni speranza in quell’eternità in cui consiste, per il cristiano, l’indefettibile bonum e, con essa, ogni aspirazione a ripristinare, nella cuna di un altrove paradisiaco, l’unità, infranta dalla morte, tra figlio e padre, figlio e genitori.
Colmare il vuoto prodotto dal luctus, recuparare il perduto: ma questo non è, in fondo, il tema del Ritrovamento del Salvatore nel tempio, un dipinto di William Holmen Hunt ispirato al passo biblico di Luca, su cui Morasso ci invita a riflettere nella pagine conclusive del suo libro, così risonante di voci abissali? Hunt è stato l’unico, nella storia della pittura, dal Medioevo in avanti, il quale, a differenza dei suoi predecessori, abbia puntato lo sguardo, non sull’episodio della disputa del giovanissimo rabbi con i Maestri della Legge, ma su qualcos’altro. E cioè, su quell’attimo in cui gli sguardi di Maria e Gesù si incrociano, nel tempio, e in cui è dato cogliere – dice Morasso – uno snodo esemplare della dialettica fra natura umana (quella di Maria) e sovranatura divina (quella di Gesù), che proprio lì, in quell’istante, si separano con smaccata nettezza, per poi tornare a riunirsi, poco dopo, in una sintesi non pacificatrice. Si tratta infatti, diremmo in conclusione, di un ritrovamento, il quale prelude a un’altra, più terribile perdita, come la madre sembra intuire oscuramente, stando almeno alle parole di Luca («Sua madre conservava tutte queste cose in cuor suo…»); di una sintesi che non pacifica e non risolve alcunché. E tuttavia il fatto stesso che si sia realizzata, in quell’interstizio minimo/memorabile di tempo, in cui lo sguardo rabdomantico di Morasso individua la vena sorgiva del miracolo, ci autorizza a vagheggiare l’utopia di una possibile coniunctio oppositorum. Di una sintesi, la cui potenza irradiante sia tale, da farci scorgere, per un attimo (ma un attimo «carico di tempo») sotto un’altra luce tanto il messaggio terroristico di cui il Cristo morto è latore, nel Siebenkäs, quanto l’incubo che Holbein fa balenare nel suo Cristo deposto nella bara, morto per sempre – morto per davvero: “memento inaggirabile” «della fragilità e dell’impotenza essenziale della materia che noi siamo», e insieme «dell’idea della catastrofe di un mondo senza possibilità di redenzione» (p. 58).
È nel cono di questa luce, separata da e, al tempo stesso, confinante con l’ombra in cui intravvediamo la sagoma dell’autore, seduto alla scrivania del suo studio, nella foto riprodotta nelle ultime pagine del libro, che si staglia il crocifisso appeso al muro, “un bell’oggetto” del primo ‘700, opera di un abile artigiano, di cui Morasso ci offre una descrizione e, insieme, un’esegesi. Si tratta di un Cristo ben diverso, sia da quello spaventoso dipinto da Grünewald, sia da quello irrimediabilmente morto di Holbein. Anzi, questo «piccolo Gesù» non sembra neppure «morto o agonizzante, ma, piuttosto, preda di un sogno» (p. 59), tanto da trasmetterci, in virtù della sua grazia, quella «sensazione di compostezza e misura» amplificata dalla luce che lo lambisce e lo circonda. Una luce che, se non ha nulla di consolatorio, ci offre, al contrario della tenebra sul cui sfondo si accampa il crocifisso della pala di Issenheim e in cui riecheggiano le parole disperate del Cristo di Jean Paul, un varco umbratile (il vuoto pneumatico del dono), in cui, vinta la tentazione nichilistica, poter almeno continuare a “rimuginare”, sotto l’egida luminosa del sogno di Dio, sul senso di quel “mandato”, al quale forse ciascuno di noi, non meno di Gesù, è tenuto ad attenersi.
Daniela Bisagno
* * *
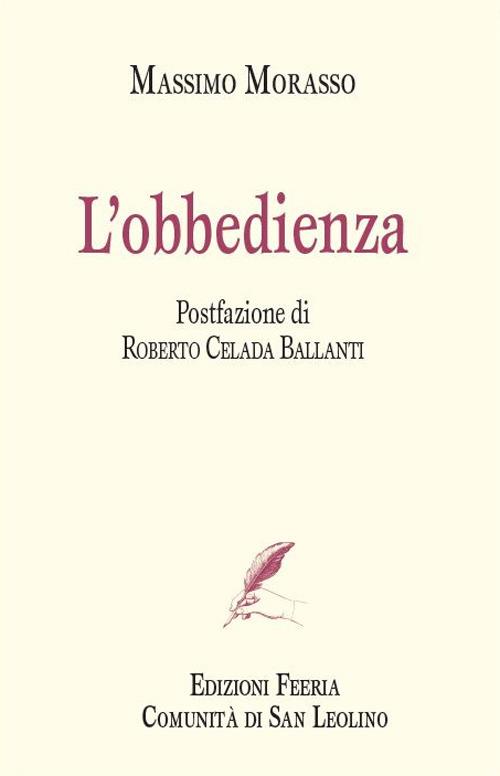
* * *
Massimo Morasso (Genova, 31 luglio 1964) è un saggista, poeta e traduttore italiano. Per ulteriori, qui.
Daniela Bisagno è nata a Genova dove vive e lavora. Si è occupata a lungo di poesia, narrativa e scienza del mito, dedicandosi a Pavese, Morante e Furio Jesi. È autrice di L’orma dell’angelo. Saggio sulla poesia di Cesare Viviani (Interlinea, 2010) e di un libro su Pascoli (La parola della madre. Traduzione e commento dei Poemata christiana, Jaca Book, 1998).
© Fotografia di Donatella D’Angelo



