Πῦρ θαλάσσιον, ovvero dell’astio inestinguibile
Senza troppa ambage, né temendo di affermare il falso, si può sin dal principio esternare che l’ultimo cimento poetico di Costa si estrinsechi in una silloge connotata da una profonda ricerca esistenziale-filosofica, la cui portata poetica si dimostra in grado di dipingere una sintesi dall’ampiezza esaustiva sulle miserie (non solo) umane.
Tra illuminazioni liriche, idilli risolti nella malinconia berciante e rimpianti dai risvolti tragici sulla campitura di una Venezia cadaverica, la voce dell’autore si districa nella brulicante sequela di stimoli esterni che, nel loro costante e doloroso trapungere la coscienza poetica narrante, sono trasportati in un gorgo di rammarico e disinganno per poi giungere alla consumazione conseguente rivolta verso ogni limite e vestigio di umanità.
Il poeta, liquefacendo nell’indagine condotta la realtà di cui esperisce il rigore mortale, risalta un quadro fenomenologico che si concretizza nell’alta definizione degli istanti, meticolosamente descritti come scarti di una storiografia del quotidiano che, al posto di essere glorificata in modalità affini alla tendenza di un certo filone di poesia, risulta interamente immersa nell’acqua putrida della sua Venezia ammorbata.
Infatti sullo sfondo della vicenda umana e naturale si staglia una pala d’altare lugubre, in cui le cose morte si confermano intese come macrocosmo di un paesaggio (urbano, se così si può dire del territorio veneziano) in cui si animano non già persone specifiche, bensì eventi generici che, per quanto siano per sé considerati, ci vengono consegnati de-personificati, innominati, e senza volto.
A fondamento di questa asserzione si rileva che tale non-nominazione trova causa in una indegnità patologica totalmente radicata nel dettato, aprioristica perfino, che sembra muoversi in una duplice direzione: la prima, che inerisce direttamente a una valutazione qualitativa delle cose che il poeta identifica; e la seconda, che invece riguarda il conseguente ribaltamento del paradigma autoritativo che interessa il poeta come cantore.
Se il reale, negli occhi di Costa, risulta sepolto nel silenzio e nella persistente afflizione della consapevolezza di un male absolutus che invade progressivamente ogni azione, ne consegue che il poeta, in quanto tale, debba vestire intrinsecamente il manto della responsabilità, sicché presti la propria voce alla sequela degli avvenimenti inconsulti che si stratificano sulla rete di Indra, appesantendola.
La conseguenza è però presto detta: il poeta rimarrà da questi impaniato, contagiandosi a causa delle esalazioni fetide di una realitas a cui deve aderire a costo di contrarre quel morbo incurabile che lo condurrà all’esautorazione del proprio ego, sino alla perdita del nome che lo identifica, rasentando la consegna genetica a un vizio di quanto egli stesso sia, incarnandone il peccato e l’anomalia esistenziale.
L’elemento su cui si fonda la poetica di Costa risulta essere, e maggiormente si conferma in questo testo che non nelle pubblicazioni precedenti, il miracolo d’infamia ed onta che innerva l’essenza delle res gestae humanae, in cui la bassezza cosmica tocca la sublimità dell’assenza e la mancanza concreta di una geografia materiale che consenta un riferimento comune di speranza che non si infonda nella fine di ogni cosa.
Quindi la misantropia che pervade l’acuta sensibilità del poeta, capace di alternare alle nature morte delle cose un alienato rifacimento della vita, si concreta non solo in una sfiducia irrecuperabile, ma in un vero e proprio modo insano di percepire e filtrare ciò di cui l’esistenza è composta.
Tant’è vero che questo sentimento si mostra ora come disillusione nei frangenti descrittivi, ora come consumata sfiducia di un canto senza origine, con la naturale conseguenza universale di προσκύνησις al nulla perpetuo che colma il silenzio di una camera del trono vuoto.
E ciò, a nostro dire, si distingue nettamente tanto da un nichilismo all’orientale, quanto da un pessimismo leopardiano: essendo il primo prono a conoscere la volontà come volontà di far diventare altro le cose, ignorando al contempo il senso radicale dell’altro, ossia il senso del nulla e dell’essere-nulla(*) compreso; e il secondo, poiché il concetto stesso di pessimo, fondamentalmente, esiste solo alla luce di un ottimo,
sconosciuto attualmente alla poesia di Costa.
Anzi, forse ci è dato di parlare di post-nichilismo quando si parla della trama filosofica sottesa ai versi dell’autore, a tal punto che è in questa direzione che la sua penna si immerge nella morchia nera della putrefazione cosmica e si fa carico di quanto più profondamente malato essudi da qualsiasi azione che chiunque (e qualunque cosa) porti a compimento, rimodellando tali suggestioni fino a porle al centro figurativo di una poesia che si può dire dispersa tra i poli della sofferenza interiore e della trasparente inautenticità dell’esistenza.
Così il dettato struttura un contrappeso ideale alla capacità di immortalare un istante per dedicare lo sforzo poetico a consolidare la mutevolezza della stessa, manifestandone così la perdita di consistenza e cedevolezza della trama dell’ἐπιστήμη; rinunciando contestualmente a un dialogo, tanto desiderato quanto irrealizzato, in cui la voce (ogni voce) poetica non può fornire un responso di segno positivo ai quesiti che a questa possono essere posti.
Di più: lo scetticismo dell’autore proibisce il conforto di ogni riparazione, fragile o meno che sia non cale: la lacrima è il segno inequivocabile di soffrire sia il possibile che la possibilità di un inganno di cui ogni essere umano è fautore e vittima.
Per questo, come già noto alla cifra stilistica del nostro, l’elemento lirico si mostra adesivo al dramma quotidiano e si cala completamente in una realtà scossa nel profondo dalla percezione del proprio sconfinato squallore.
Di conseguenza, instaurando un contraltare macabro di sostanzialità funesta, la domanda più spontanea da rivolgere al testo potrebbe insistere sul confine di quanto sia empatia e quanto sia con il soggetto lirico; ma su questo fatto si tornerà a breve giro.
Perfino la rosea ipotesi in Costa costituisce una trappola in cui la resa dei conti è a portata di mano, e conduce alla realizzazione della meschinità a cui ognuno di noi (e ogni cosa) procombe.
Una tale mancanza di speranza meglio si vede quando viene introdotto il tema della montagna come immagine del passato (ma anche del futuro e quindi come morte certa) che pesa sulla laguna, con la conseguenza che, al di là del valore fortemente simbolico, il dettato si confermi totalizzato in una poesia dal valore fortemente reazionario in cui il disagio, dopo aver nemmeno tentato un gesto salvifico, manifesta l’intima natura (fallimentare) della fenomenicità solo per recuperarne le lacune di significato.
Non a caso nel testo l’aspetto aurorale cozza con la laida materialità di un’esistenza a tal punto disperata da non poter altro tentare che una preghiera in extremis, con la sua mormorata desolazione.
Sul versante stilistico ci preme dire che, complimentando una narrazione episodica l’opera non si discosta, né si esime, dalla pulsione spasmodica che si può rinvenire nella trattazione poematica che effettivamente denota la scrittura di Costa.
E ciò ci sembra argomento che prova senz’altro quella pulsione intimamente adesiva del soggetto poetante all’io poetico; pertanto, se non anzi proprio per questo motivo, l’ego fictus e l’ego certus tendono a coincidere nella pagina, dimostrando quanto e come e l’uno e l’altro siano inevitabilmente delusi, al limite della nausea, dalle sorti della vita umana.
Pertanto non ci sembra di doverci sbilanciare in speculazioni incerte quando si espone che il senso di colpa che avvelena i testi del nostro condizioni la percezione della vita, confluendo in un elemento straniante nel dettato e giungendo in ultima istanza a una osservazione più simile allo studio anatomico e scientifico della materia che il poeta ha innanzi.
Ma non solo a questo si riduce la matrice poetica dell’autore né tanto meno da questo fatto dobbiamo dedurre una narrazione onfaloscopica o, comunque, proprio-centrica, ovvero fine a sé stessa.
Possiamo infatti accostare alla precarietà propria di un inverno purgatoriale e dell’amore difettoso quel concetto di biografismo penitenziale, ben noto alla penna dell’autore, inteso a una mortificazione che da una struttura eso-poetica invesca anche ciò che sia endo-poetico.
In ultima istanza il ποιέω in Fuoco greco si manifesta sofferente dell’incapacità, poiché conscio di ciò, di confinare (anche provvisoriamente) l’ipnosi funeraria e saturnina che pervade e mette in relazione ogni parola con gli epifenomeni esterni, in cui dominano l’irrisolto e l’incompiutezza malinconica dei fiori finti.
Ne consegue che, disperso fra contemplazione e disprezzo, il dettato del veneziano (di adozione, e con suo esplicito rammarico) si dimostra strinato dall’affanno del miracolo che non si compie, e l’attesa negata e risolta un tanto nel castigo di una sofferenza imposta in termini sanzionatori, che però non assurge alla compensazione effettiva, e nemmeno mira a una rieducazione di una vita vissuta nel difetto e nello scarto fra ideale e reale.
Così, concludendo, si manifesta una poesia che tanto si cala nella vita, esponendosi anche alla volgare lordura della stessa, tanto richiama a sé l’esasperata necessità della scrittura. E, forse, è in quest’atto consapevole e testimonianza di dolore l’unica ragione che l’antropocene può trovare e addurre come motivazione alla propria ostinata insistenza.
Un recupero obbligato di un significato, affinché questa forzatura possa auspicabilmente giustificare ciò che giustificazione, pur troppo, non ha. Questo, perlomeno, subordinandosi all’accezione per cui la scrittura sia il linguaggio più vicino al nulla ed alla morte e, per questo, più vicina alla vita che null’altro.
La conclusione tanto agognata quanto preordinata alle cose non può che determinarsi in ultima istanza nell’orrore del taglio decisivo, dell’incavo che non concede altra certezza che la propria presenza sanguigna e la fermezza della mano che seziona per ricomporre margini di confini ideali (seppur provvisori) di labbra che non osano più trattenere il proprio dolore, manifestando un astio non estinguibile.
Carlo Ragliani
* * *
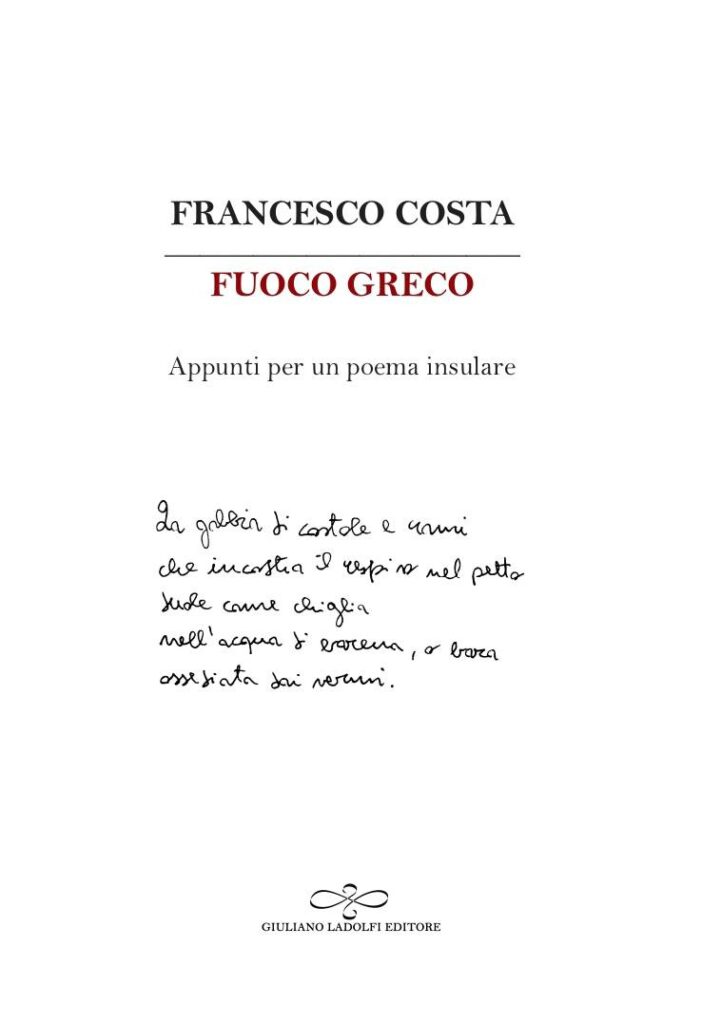
* * *
A volte l’orizzonte medita
antica vendetta che all’alba
accenna alle barche
lente e colorate
complici
distraggono l’occhio e disegnano
paesaggi irreali allo specchio
la laguna
lenta rimesta veleno
ed erode un mattino brinato.
*
Sgrano come un rosario le vertebre
di marmo della terra, prego
ed impreco e m’inerpico
sui gessi di fiato rattrappito
che inforcano la bassa atmosfera
di un agosto, a Venezia
il carnaio insudorato di una mandria
in cerca del mio stesso pascolo
mi incuriosisce – Dio pastura
nelle calli più strette, per meglio
guardarci azzuffare
soffoca la gavotta delle pance
strabordanti e dei sudari indossati
come pareo, per nascondere le gambe
e il ventre dalla vita
che qualcuno, dicesi, conduce
al di là dell’acque
nelle isole smarate
negli slarghi
intorcolato, come un’edera
alla forcola dell’alba
guardo il cielo denso di sale
indurito a forza di bestemmie
spero a volte in un’inondazione
altre volte in una bella dormita
altre volte in altre volte
meno solide, che crollino
su queste case e le rischiaccino
nel mare – tra i granchi
e i fanghi del fondale.
*
Ho sentito poi chiamarmi
per sotto il formicaio
il profumo dei sepolcri
degli anni inchiodati nelle casse
e i canti sommessi suggeriti
ai tetti: attento
presto si muore
pure senza morire
e con quanto poco, quanto poco
si fa una vita.
Guardo passare
tutto
come macchine o un’estate
dal bordo della marina
dalla pensilina dei tram
nauseabonde giornate d’ottobre.
Con l’amore in avanzo
al campo santo di me, ho amato
mentre guardavo la laguna
con la stagione
cambiar colore
mentre guardavo sbiancare
i monti dietro e le guance
andarsene
con la Bora che muore
il tuo fiato sospeso.
*
Nel fracasso della carne
e l’aruspicina miserevole
di mezzo pubblico
muta la pelle il serpente
di lontano studio
come grigio avvoltoio
lo strano parto
pomeridiano
aspettando
sempre
il carcame
venisse
una volta tanto
a cavarsi fuori una preghiera
dalla pancia di cemento
col sudore
della fronte sua.
* * *
NOTA:
(*) Magistrale in merito la testimonianza di Emanuele Severino, a cui si fa rimando nella sua completezza.



