Elisa Ruotolo scrittrice e poetessa, è nata a Santa Maria a Vico (Ce). Con l’editore nottetempo ha pubblicato nel 2010 il suo libro d’esordio, la raccolta di racconti Ho rubato la pioggia. Il primo romanzo arriva qualche anno dopo: Ovunque, proteggici (nottetempo 2014; Feltrinelli 2021). È del 2018 Una grazia di cui disfarsi. Antonia Pozzi, il dono della vita alle parole (edizioni RueBallu), cui fanno seguito – nel 2019 – la curatela del volume Mia vita cara. Cento poesie d’amore e silenzio di Antonia Pozzi (Edizioni Interno Poesia), e la pubblicazione della raccolta poetica Corpo di pane (nottetempo). Il suo secondo romanzo Quel luogo a me proibito (Feltrinelli 2021) è tradotto in Francia dall’editore Cambourakis. Ultime pubblicazioni Il lungo inverno di Ugo Singer (Bompiani 2023), e Luce (Tetra 2023).
* * *
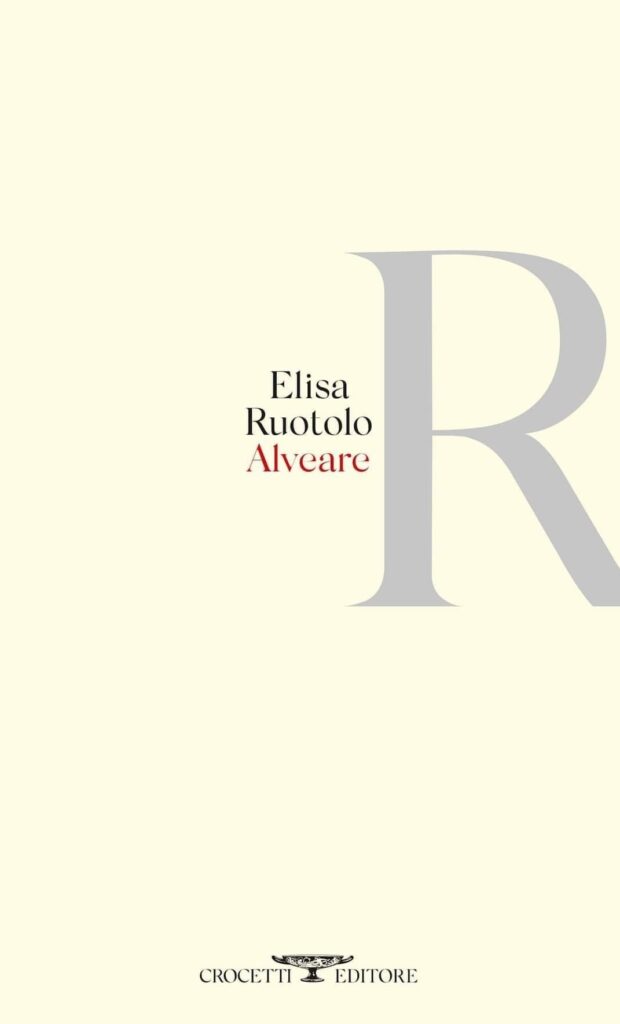
* * *
da L’APICOLTORE
Il buio è madre
tutto accade in un ventre.
La luce poi lo insidia
diventa così tanta
da chiudere gli occhi.
Sotto le palpebre restano scintille
ronzanti come sciami.
Tu puoi lottare per tenerla fuori
ma è luce che t’insegue
ovunque
più invadente dell’erba
a primavera, più sfrontata dell’ozio
che divora il gesto,
più assidua del malanno
nel tentare la ferita.
E quando penetra nell’alveare
imbratta il nero
lo trafigge.
Carezza un brulichio di affanni
una fatica che brucia
come sale.
Lo sentite?
Sentite anche voi là dentro
il rumore delle vite?
Ognuna che lavora, vuole, rinuncia,
edifica e distrugge
uccide
e poi alleva.
In questa meccanica non hanno bisogno
di me ed è la mia pena.
Pur non sorvegliando
so che quel lavoro continuerebbe
– come il desiderio a spingere
la rinuncia a incrudelire
la distruzione a fare danni fino a patteggiare
con la pietra che cresce.
È la morte ad accudirle
nella culla, e poi la vita le distenderà
nell’asciutto nido d’una cassa.
Mi avvicino senza essere visto
con la cautela di chi ha paura.
Di me hanno un’idea incerta
sono per loro una specie di infinito
che minaccia
– un estraneo
l’orma di un ordine primario
la possibilità di non discendere dal niente
e non doverci tornare
alla fine.
Amarli? Di loro ho bisogno
o non sarei
– come non esiste fondo senza mare
né figlio senza madre
o grano senza un seme
divorato dalla terra.
Il pastore può forse amare
la moltitudine che si dà ciecamente
al suo governo?
Non è forse dominato dal ritmo
del branco, dal belato che comanda
di restare sulla pietra a sorvegliare,
a contare il patrimonio in zecche e lana,
a vegliare quell’odore di stalla.
Il pastore non ama
ma calcola, pretende,
teme la disgrazia della perdita
e nel suo buio invidia
chi ha giorni fatti di stanze
e di casa.
Come lui lo è del gregge
io sono la creatura dell’alveare
che ogni giorno fa di me l’apicoltore,
il dio d’un nettare che sgorga
non in obbedienza d’un volere
ma in soddisfazione d’una necessità.
Sono imperfetto e fragile
e come gli dei di sempre
annodo alla terra il mio bisogno.
Resto lontano, al riparo
dall’assalto – che non venga a toccarmi
il veleno dello sciame
turbato dalla peste della mia fame.
Dentro è caldo di folla e buio
la mia onnipotenza invece sta nel chiaro
risponde al nome che meno desidero
sa d’una eternità destinata a finire
mentre loro – i vivi dell’alveare
si rinnovano.
Ammassati in un inferno ridotto in scala
pulsano d’un calore che mi esclude,
che osservo senza comprendere
restando incompreso.
Il rischio di provarci, di ferirsi
disgusta ogni voglia
– il mio sapore non sazia
non ho miele da dare, io.
*
da VOCI DALL’ALVEARE
SEDICESIMO GIORNO
La Regina
È un roveto che scotta d’ira – questa casa
ha i muri tramati di collera
e un vociare insistente che ostacola
il riposo. Ho dormito finché ero niente
poi la pace se n’è andata.
Restare fermi non dà quiete
fermi sono i prigionieri
i bambini confinati negli spigoli – in punizione
i corpi traditi dalla malattia
o le ferite che non passano.
Ferme sono le mani dopo aver colpito
perché – in allerta – s’aspettano il ricambio.
Ho tutto in me: la colpa del recluso
la paura dei piccoli
lo smarrimento degli infermi
e un taglio di quelli che non danno sentore
d’arrivare al mattino.
Il destino è giunto mascherato da offerta
e io l’ho preso – quel dono – e stretto col terrore
di esserne degna.
L’ho preso e già non lo desideravo.
Perché io?
Lo sguardo livido e affamato delle sorelle
mi accompagna da allora.
Uguali nelle culle, potevo essere
un chicco di quella moltitudine
ma qualcuno mi ha vista e separata
– trebbiata come grano dalla pula
e anche se mi nascondevo, mi ha indicata
per prendermi tutto: i fiori, il sole, la vita delle altre.
Non sapranno mai quello che mi tocca
pesa troppo la fatica a cui le condanno
generandole
almeno quanto l’incapacità di cibo grava
su di me – che sgorgo vita senza posa.
Strano potere il mio, se per esistere
ho bisogno d’aiuto
se reggo una dimora intera
e fallisco a far salire un castello di carta.
Madre di tutti, non governo me stessa
inganno l’istinto comune
ed è triste dipendere
triste che vada contro natura proprio io
che più di tutti
l’assecondo.
Resto figlia di cure sfrenate
che mi negano il digiuno, la fatica, il caldo.
So che dovrò vivere a lungo
ma potrei morire in un istante
per un minimo sforzo o uccisa
da un tocco di luce.
Mi nutrono, ma odiando questo corpo
eterno, materno, che spinge avanti un’ombra
nuova e antica.
Nessuna clemenza può venire da chi attraversa
giorni contati, l’occhio referta la sua razione scarsa
senza goderne e la freccia più sicura
è quella che sa pungere
– è la mano che ti cura tenendo
a fior di pelle
il suo veleno.
Il futuro degli altri – più del presente
non è mio
e a questa sorte mai scelta
non trovo rimedio. Vago di cella in cella
inquieta come una madre qualsiasi
il cuore livido di chi è troppo in alto
e in fortuna per essere amato.
Generare vita e temerla
impietra il cuore, ti mette in dosso un tempo
legnoso al tatto – già pronto a farsi cenere.
Le mie figlie sono l’urgenza e la lebbra
il dovere ma anche l’attesa d’una peste
che s’intana nei miei lombi.
Vivo per il loro moltiplicarsi
ma so che da loro arriverà la fine
il giorno a cui non si può chiederne
un altro.
So che un mattino sentirò il mio veleno
spingere e la paura armare in difesa
la mia lama.
Ne abbiamo tutti una nella carne
la crediamo in riposo
invece lei ci annera il pensiero
ci intorbida il gesto
fa della madre una rivale
e della figlia non più il prolungamento
e l’attesa
e il futuro
ma il taglio netto, l’urto contro il tempo
– la promessa che nulla resiste
allo schianto.
La famiglia ora mi cresce intorno
e spinge fin dentro le mie stanze
dove nulla è fuori calcolo
e l’inverno non arriva.
Ci sarà un mattino, però
giungerà a un’ora incerta e incrinerà
le pareti, creperà l’intonaco
porterà lo scontento del vuoto
le fenditure alle travi maestre
lo scalpiccio delle suole in fuga
l’acciottolio dello sfratto
il bagliore indecifrabile degli incendi
in fondo – la faticosa scelta tra ciò che prendi
e quel che lasci indietro
e in alcune vesti l’odore greve del tradimento.
Accadrà e la mia lama non saprà far durare
questa casa in cui vivo da schiava
sottomessa all’urgenza di ripopolarla
suddita dei figli che partorisco
perché siano munti fino all’ultima goccia.
Chi potrà guardare questa febbre mia
senza desiderarne il delirio
senza disprezzare quel sudore da manovale
che nulla spartisce col mio piacere
col mio salire alto, dove più forte è
la luce e dove le altre non saranno mai?
Chi è indegno del chiaro non saprà
preferire la notte
odierà ogni spiraglio che saprà tenere il conto
di quel che perde.
Nei miei fianchi giace dormiente
il futuro di queste stanze
e lui mi divora
mangia ogni pensiero, ogni paura
scalda la mia sostanza più nascosta
– la nutre.
Il mio potere mi condanna a infittire
una genia di servi da cui dipendo
mentre vivo, divento nelle loro mani
la bambina che mai sono stata
e che morirebbe – se non fosse nutrita.
Sono la madre-infanta
un pensiero costante in una casa
che non lascio riposare
la grande pena è di regnare
protetta, abbandonando
i miei nati a un’operosa povertà
quella dei figli del popolo
che fin dal colostro accettano il privato
mistero di non avere tempo per ridere
o per giocare.
*
da VOCI DALL’ALVEARE
VENTUNESIMO GIORNO: LE API OPERAIE
La Guardiola
Cane di un povero gregge
generale di milizie stremate
sorvegliante di case da martirio
– o di cura
sono tutta lì
tutta nello sguardo.
Ispeziono vite, sorveglio anditi
e clausure
distinguo dal nostro
ciò che è straniero.
Per la conta del legittimo stringo
ogni porta, ne faccio fessura
labbro chiuso agli appetiti del fuori.
Resto insonne, in veglia fin dall’inizio
ed è la mia morte rovesciata
– palpebre attente a sbattere via
riposo e indolenza.
La chiamo amore, questa ossessione.
Per semplificare chiamo dovere
questo martirio di giornata.
I nomi ora faticano a dare pelle
e restano vuoti
imprecisi oltre le cose che tremano.
Separare il chiuso dall’aperto
non è innocente
distinguere è addensare ombre
è scuoiare l’agnello
e indossarne lo scalpo.
In questa Casa non vi è comunione
qui non si impasta vita con vita
qui non esiste mensa
tutto abbacina e brucia di terzana.
Indossiamo la trama del buio
e ci aggiriamo muti
carichi di lanterne cieche.
Il silenzio è la tentazione più forte
da che ha preso stanza il rumore
ed è difficile – stare al mondo in questa notte
disfarsi nel guardare.
Il lupo non è fuori, nell’erba alta
ma dentro, tra le quotidiane ceneri.
Parlatemi del giardino – ve ne prego
suggeritemi poche parole per immaginarlo
oltre la soglia che custodisco.
La Casa respira e mi abita
ha i canini del botolo e gli artigli del rapace
è levigata da un cattivo amore
eppure rilascia l’indistinto calore
delle viscere.
In lei perdo i miei anni e la quiete
dei polsi.
La Casa vale più di me.
* * *
Il Mondo non è che questo: un enorme Alveare in cui ciascuna vita ha un suo ruolo e un destino ingiustificabile. Visti dall’alto siamo come api: febbrili, follemente laboriosi, spesso crudeli e sottomessi a irragionevoli geometrie.
Mansueti, ma anche capaci di fissare il buio con disobbedienza, siamo un brulicare di vite mosse da un’idea che ci impegna a edificare ciò che domani sarà disperso. In questa tragedia greca ripetuta all’infinito, a ciascuno è data la sua goccia di veleno.
Le voci della Casa del Miele si alternano seguendo il ritmo del loro venire alla luce (dalla Pupa, inconsapevole della sorte che l’attende, al Fuco creatura troppo distante dal sole per poter sottostare alla laboriosità che nutre e sfinisce l’alveare). Raccontano la furiosa virtù del generare e la perversione della castità; il saccheggio imposto e subìto; le schiavitù consumate in una dimora affollata di ombre e poi la fame del mucchio che divora il singolo, esponendolo a qualsiasi peste voglia aggredirlo. Sono voci piene o solo accennate, eppure ciascuna rivela il suo bisogno di essere, di vivere, di alimentare una ciclicità che rappresenta – per noi, come per le api – l’unica eternità possibile. (Elisa Ruotolo)



