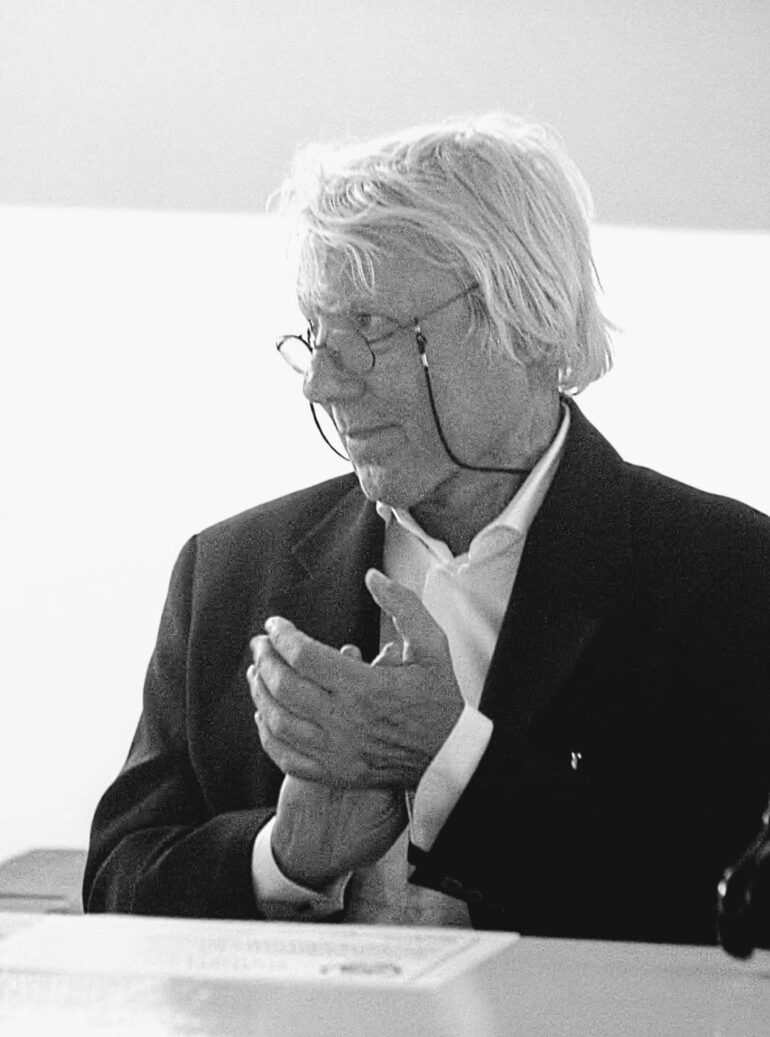La più recente raccolta di versi di Claudio Recalcati esce dopo un intervallo di oltre dieci anni dalle precedenti, riprendendone il filo in modi originali. Microfiabe (Mondadori 2010) si presentava come un’indagine attorno al tema del male nelle sue molteplici manifestazioni fisiche, morali, esistenziali. Non il male astratto delle grandi tragedie, delle quali abbiamo in genere conoscenza indiretta, ma quello concreto dell’esperienza vissuta, ad esempio la malattia incurabile che colpisce una persona cara, a cui è dedicata la prima sezione, significativamente intitolata “Vicolo dei macellai”. Per un tema così importante esiste addirittura un “genere” filosofico, quello della teodicea; ma poiché qui non c’è traccia della religiosità, in genere melassosa e burocratica, oggi in voga fra molti giovani, si afferma che “L’accettazione del male è la più grande / forma di coraggio. Forse / sono un vigliacco, e lo sussurro a malapena”. La malinconica pace dell’accettazione si alterna nel libro a un più frequente sentimento di rabbia sorda, quella che qualunque essere umano, specie se non schermato da ideologie consolatorie, sente sorgere in sé di fronte all’inspiegabile idiozia della sofferenza. Lungi, infatti, dal sollevare verso il trascendente, per Recalcati il male fa sprofondare chi ne è colpito verso una dimensione subumana e materica. È questo l’ambito, tutt’altro che oniricamente consolatorio, in cui la porosità fra mondo umano e animale messo in opera dalla fiaba ha una rilevanza specifica sul discorso del libro. Il quale si sviluppa sondando il tema nel contesto di vari tipi di rapporti sentimentali, quelli autobiografici individuali e familiari (le sezioni “Una sconfitta parziale” e “Microfiabe”), quelli letterari (“Il seme ferito”, su Campana e la Aleramo), per poi concludere, dopo due brevi intermezzi autobiografici, con il “romanzo d’appendice” de “L’ortolano di Balzac”, truce vicenda di violenza familiare in bilico fra allucinazione e realismo (si riconosce l’ambiente dell’ortomercato milanese). Il male trova un contrappeso negli affetti familiari, nella forza dei legami sentimentali (in particolare, per la moglie e le figlie nella sezione delle “fiabe”), anche se in Recalcati l’esorcismo è sempre parziale e lo sfondo rimane sinistro e minaccioso. In effetti, il titolo del libro, più adatto a Vivian Lamarque che a Recalcati, non indirizza il lettore verso il senso ultimo della raccolta. Ne ricordo una versione precedente con un più appropriato In pasto all’orco (ora sottotitolo della sezione “Microfiabe”), il quale portava in primo piano il tema della violenza autodistruttiva e cannibalistica dell’umanità, lasciando l’origine fiabesca sullo sfondo, come in effetti si verifica nei testi della silloge.
Rispetto alle infere atmosfere di Microfiabe, Vittima delle rose appare come una sorta di risalita alla luce, avvenuta grazie all’amore. La raccolta è infatti una sorta di canzoniere, sviluppato attorno a un tema non meno impegnativo di quello del libro precedente. Le rose di cui l’io poetante si definisce come vittima non hanno nulla di mistico; sono, secondo tradizione, simbolo di passione amorosa, qui declinata in senso carnale e psicofisico, senza alcun riflesso metafisico. “Appartengo ad una razza che brama / una razza a tratti luminosa a tratti oscura / che non conosce requie”, dice di sé il poeta. Il desiderio è energia vitale, l’incontro casuale con un nuovo amore ridà voglia di vivere e sfrontatezza: “Del cancro mi sbarazzo, / di funghi e di coliti, / d’ansie e di paure. / Ritorno bello pure / e mi innamoro, / vivo l’età dell’oro / in barba alle iatture.” Invece di lutti e dolori, va celebrato ora “quell’abisso / che è la gioia”, “quell’unico sai / momento in cui divieni / l’occhio luccicante di tua figlia, / la donna che per sempre amerai.” La passione dell’io che si definisce “contento e mediamente felice / ed ostile a una vita normale” scatta, come è naturale, per un’anima gemella, con la sua “assoluta non aderenza / alla vita comune.” Questo sentimento un po’ anarchico del vivere è il medesimo dei compagni di viaggio poetico, richiamati come vecchi amici e non come citazioni da esibire, da Villon a Pound, da Pasolini a Dylan Thomas, dal Belli a Porta.
Quest’ultimo non viene nominato ma è presente nella protagonista della sezione più lunga, “Victime de toutes les roses”, l’unica in terza persona, che narra la vicenda di una tal Ninetta, costretta a lasciare la provincia per via dei guai causati dalla sua libertà di costumi e dalla sua ingenuità, trasferendosi poi a Milano, dove gli “irregolari” possono mimetizzarsi meglio. È un’altra versione di un appestato sociale da aggiungere a quelli citati in precedenza, un’analogia o una maschera per l’io lirico che nel resto della raccolta si esprime in prima persona, chiarendo a proposito degli esseri umani: “Io non sento più / la loro vicinanza, così che mi innamoro / più facilmente d’un ladro, del non decoro / perché lo sento meno vile, più prezioso / che non un convenevole altezzoso…”. Mentre “‘Questi’ ci raccontano fiabe / della Bovisa storie, / memorie di vecchi”, “io / che non invecchio mai / sento la forma sottile delle tue mani / sfiorarmi il corpo di seta, / sento la dolce tortura sul corpo / ferito dalla seta / dei nostri hotel, stamberghe” in cui restano tracce dell’eros, un rivendicato giovanilismo contro “l’eterna sconfitta” dei “Questi” citati all’inizio. Tale vitalismo dell’eros ha però una duplicità intrinseca, manifesta fin dal titolo del libro. Chi parla si descrive come “vittima delle rose”: non si controlla né si decide il sentimento e il desiderio senza i quali non c’è vita, ma con i quali non c’è pace. In queste cose si agisce o si è agiti? C’è un limite ottimale oppure no? L’amore, si afferma, “inaridisce nell’esagerazione, / la bocca inaridisce per troppe parole / il tempo si accartoccia nelle menzogne. / Troppo lodare uccide… / è intimo l’amore, non universale. / Il resto è un tumore estratto da un polmone.” È un passo in cui si sovrappongono il tema etico e quello poetico, rivendicando quella misura ritmica sempre giusta che Recalcati possiede per natura, e che ha affinato nel corso degli anni. “In poesia si dice ancora ‘Ti Amo’? / O sembra una stortura ottocentesca?” Si dice ancora, pur se di rado nella bigottissima contemporaneità, e Recalcati l’ha detto in modo compiuto e persuasivo in questo libro.
Edoardo Zuccato
* * *
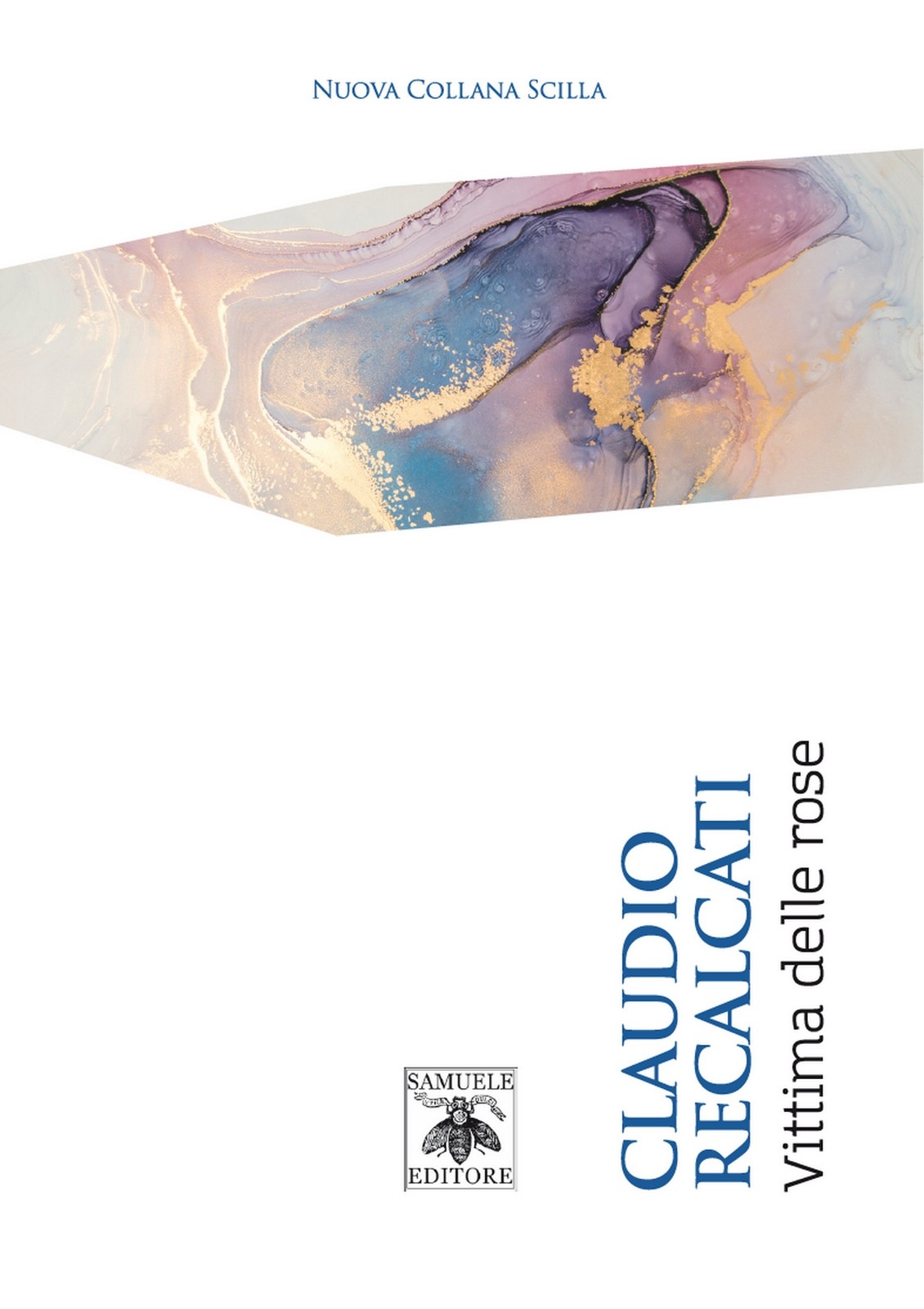
* * *
Claudio Recalcati è nato il 18 novembre 1960 a Milano, dove vive attualmente. Ha pubblicato le raccolte poetiche Riti di passaggio (Campanotto, 1995), Senza più regno (Lions Club Salerno-Premio Alfonso Gatto inediti 1998), Un altrove qualunque (Moretti & Vitali, 2001, Supervincitore del Premio Internazionale Eugenio Montale 2002), Microfiabe (Mondadori, 2010, Premi Suio Terme, Tronto e Antica Badia di San Savino), Cartoline dell’addio (Stampa2009, 2013) e I barlümm d’un barlafüs (Abeditore, 2018, vincitore come inedito del Premio letterario Città di Legnano-Giuseppe Tirinnanzi 2015, sezione dialetti). Ha tradotto diversi poeti per “Testo a fronte”, curato con Edoardo Zuccato la traduzione in milanese dei testi di Franҫois Villon, Biss, lüsert e alter galantomm (Effigie, 2005). Ha collaborato alla stesura del testo universitario (con i prof. Carlo Maria Bajetta ed Edoardo Zuccato) Amore che ti fermi alla terra (Isu Università Cattolica, Milano 2004). È tradotto, in francese, sulla rivista “Traduzionetradizione”, dalla poetessa Sylvie Durbec.
Edoardo Zuccato è nato nel 1963 a Cassano Magnago (VA). Ha pubblicato le raccolte di poesia in dialetto altomilanese Tropicu da Vissévar (1996), La vita in tram (2001), I bosch di Celti (2008), Ulona (2010), Tèrman e ricord (Elliot, 2021), e in italiano Gli incubi di Menippo (2016). Un’antologia del suo lavoro è apparsa per Elliot nel 2024, Trent’anni in dieci minuti (Poesie scelte 1987-2023). È autore di diversi saggi sulla poesia inglese e la traduzione e ha curato numerose edizioni bilingui di opere di poeti inglesi romantici e contemporanei fra cui Samuel Taylor Coleridge (2018) e Thomas Hardy (2022). Una scelta delle sue versioni, in italiano e in dialetto, è il quaderno di traduzioni Il dragomannno errante (2012). È presente in varie antologie, italiane e straniere, e suoi testi sono stati tradotti in diverse lingue tra cui inglese, francese, portoghese, spagnolo, russo, arabo, cinese e giapponese.
* * *
© Fotografia di proprietà dell’autore.