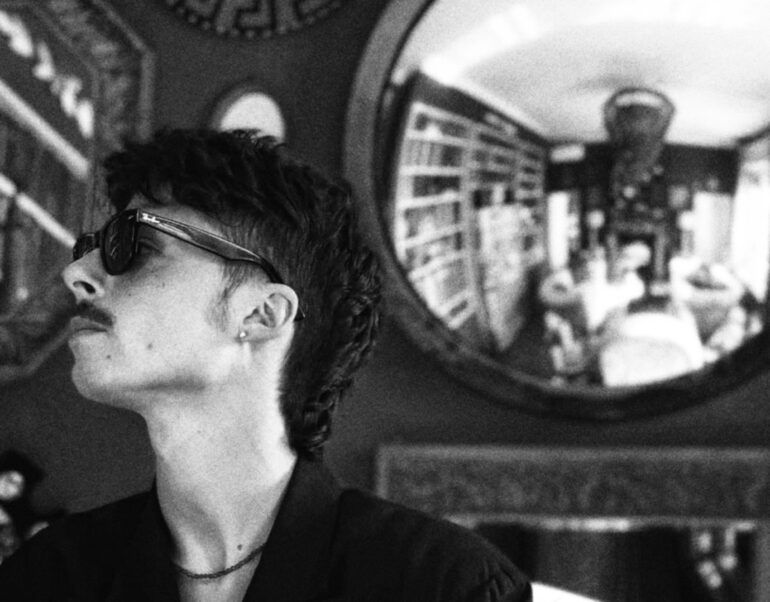Nella corona del sole nero: l’ufficio delle tenebre di Giorgiomaria Cornelio
«Un altro ciclo s’è sveltito.
Un’epoca, con la sua
dottrina d’eterno,
è tramontata».
Le tenebre dell’Ufficio di Giorgiomaria Cornelio sono le quiete acque oltre i monti cosmici, i limiti del mondo dove tramontano gli esseri celesti che animano le costellazioni e le divinità che incarnano le stelle. Nella coltre del nero, le scintille di un’ossidiana veste del nulla in cui risplendono le gemme di tutti i colori in procinto di aurora, in quell’oceano oltremondano che il sole egizio Ra attraversa ogni notte sulla sua Barca dei Milioni di Anni, lì si compie la «lunga notte del possibile». La notte dove lo spirito vitale degli sciamani discende in virtù di essere inghiottiti o di assumere volti animali, come i saggi sumeri vestiti di carpe e i dragonici naga, che insegnano le arti della civiltà e i tesori della perfetta realizzazione. La dimora da cui irradia la sorgente di tutti i tempi è anche il soffio in cui una civiltà si disperde, spazzata come un mandala kalachakra. Seppur questa sorgente vivificante sia stata inombrata nel cosmo cristiano, dove ciò che è ctonio decade nell’infero, Cornelio riprende la voragine tra i nostri due secoli nell’omonimo rito liturgico della Chiesa cristiana da cui prende il nome l’opera, in cui la flebile luce dell’ultima candela viene nascosta dietro l’altare nella più completa oscurità. Allora si scatena lo strepitus, il fragore della terra che trema alla morte del Cristo, finché la candela non risorge dall’altare, per essere poi spenta, a segnare il compimento del Regno. «Ed ecco, le quindici candele/ si spengono», dice Lisa, stesa da più di un secolo sul letto di ferro battuto della civiltà industriale, «è l’ora dell’eclisse». La Storia si oblia quando si rovescia girando le sue spire.
Fine che Cornelio rivela non essere definitiva. Qualcosa si agita oltre l’apocalisse, il fragore riecheggia nel tremolio della fiamma nascosta, e così «lo strepitus è la figura di un pericolo che salva, di un allarme che non distrugge, ma piomba a scuoterci i sensi, per annunciare un’altra possibilità di visione». La tenebra e l’apocalisse significano l’eclissarsi di Dio MA non del sacro, non del divino e dei suoi abitanti, «Perché un mondo nuovo/ non è per forza un altro mondo,/ ma questo qui, un momento dopo/ la sua eclisse». Una eco a Buber, che va ben oltre la banale contrapposizione del Dio eclissato, il cui volto nascosto nel secolarismo continua ad essere presente nell’invisibile. Quando la tenebra irrompe, diventa fondamentale «curarsi della luce rincasando nelle tenebre», quella luce che il Sole Nero, lo Yahweh Saturno genocida che infesta le nazioni con l’estrema destra, divora scatenando le sue mandrie di nazifascisti senza emozioni per rendere le nazioni le teocrazie di un dio invertito.
«Oh mio tiranno, non c’è disfatta che basti
a darvi ragione. Non voglio servire
la cronaca di questo secolo,
ma cancellare il mio nome dal vostro».
Abdicando al Saturno che falcia gli storti, Cornelio attinge alla luce nera dei maestri sufi, ripresa da Najm al-Din Razi ed Elémire Zolla. Il nero dove il sufi discende in rimembranza della visione che precede l’immagine, del suono che è non-suono. L’epoca segnata dai monoteismi dell’Età dei Pesci, «con la sua dottrina d’eterno», insegnò ai mistici degli ultimi 2000 anni che il dio unico poteva oltrepassarsi tanto nell’ineffabile altezza dantesca quanto nella nulla assenza di Böhme. Il buio che i mistici attribuivano all’abissalità del dio, quel buio è passeggero. Di contro è lì che Najm al-Din Razi riprende, assieme a molti altri maestri, i colori della divinità. Sono i retaggi sufi dell’isolamento sensoriale in cui si pratica la rimembranza dhikr, particolarmente cara all’ordine Kubrawi. Se la dottrina dei seguaci del Libro professa l’aniconia, così non è per chi vede il dio, per chi ha occhi di brace e gemme di lapislazzuli come iridi. Quando il dio e la dèa comandano il cuore, le immagini rivelano direttamente le verità. I Kubrawi riprendono che all’inizio emerge un blu profondo in diverse sfumature, che sono le sfumature dell’anima materica, per poi ascendere nel verde quando l’anima si pacifica. L’eccitazione spirituale dal verde irrompe nel giallo e nel rosso, colori dello spirito più alto, fino a sfociare nel bianco. Così ce li presenta al-Baghdadi nel suo Tuhfa, tutta l’iridescenza dell’arcobaleno è rievocata tra il nero e il bianco. I colori che si rivelano al sufi disvelano la natura divina, dai toni più vivi man mano che l’anima del sufi si rischiara, fino a diventare incolori, sfociando in dimensioni ultraviolette. Allora la luce viene detta bianca o nera, non per indicare il bianco e il nero, ma l’impossibilità di vederne il colore oltre lo spettro visibile. La poesia di Cornelio è così, una visione di chiasmo che diventa favola. L’opera trasmuta il retaggio della barbarie genocida, lo stupro dei vecchi sui bambini, per evitare che suppuri in risentimento, «Con le bandiere dei nemici/ la nazione liberata ricavò grembiuli/ per bambini. Con le divise,/ cappotti». Così dicono le piccole creature, quelli che restano: «Dovevamo vendicare,/ e invece impariamo dall’Edera:/ non quando strangola,/ ma quando spacca/ – quando sparpaglia».
Nella ruota dei grandi cicli, la memoria storica può essere dolorosa e castrante, e quindi tentarci di tagliare ogni rapporto, ma ciò non farebbe altro che imputridire la terra. Ségur l’asino detta, «cogliete le zizzanie e/ legatele in fasci, ma/ che nessuno le bruci», perché dirà la bestiaccia Volpe «quale generazione/ può vivere senza perdonare/ quelle precedenti?». Più che cancellare, per Cornelio è meglio guarire trasfigurando e convertendo, come la vecchia fornace di Valle Cascia resa teatro dall’Associazione Congerie. «Ora parla il Padrone./ Sarà l’ultima volta» perché «ciò che è stato deve per forza ripetersi?», chiede uno dei padroni, Mozzicafreddo, mosso a dubbio. Cornelio abdica le provocazioni di un capitalismo feudale senile e fascista con lo spirito di un vero bodhisattva, professando un amore luciferino, il serafino più alto, che per il mistico sufi al-Hallaj è colui che più di tutti ama il dio, e da questo viene ingiustamente condannato.
«E per farvi un ultimo torto,
oh caro padrone,
mio oppressore,
io ti amo».
*
IL REGNO DELL’EDERA E IL TRIBUNALE DEGLI ANIMALI
«Sento, tra le cose umane,
il confine che diaspora,
che cerca altro mischiamento.
Dopo l’epoca dei divorzi.
Oltre l’epoca dei sigilli»
Il buio non è solo luce nera. Se i colori sfavillano, è perché qualcosa si muove e riflette quella luce nei suoi occhi, nelle sue spire e squame, sul suo manto. «Eppure, questa specie/ espatria lungo i tempi» dice Lisa in sentore della Volontà schopenhaueriana, «la vita s’innesta sulla vita/ non termina, ci continua,/ senza compimento». È vero che in questa voragine ritorna il passato, eppure qualcosa lo eccede sempre. «Come il buio che mi ha partorita/ io partorisco buio» sembra chiuderci in un eterno ritorno, ma non è così, perché «in nessun modo l’uomo coincide/ con la vita dell’uomo». Lì dove il dio umano, troppo umano, e quindi il dio capitale, vede la fine definitiva, l’eclisse spalanca al contempo la Porta delle Sfingi. Nel Levante antico, all’estate arida seguivano le piogge autunnali e invernali, mentre in Mesopotamia l’autunno inaugurava il rigonfio pluviale dell’Eufrate e del Tigri. Le sfingi levantine disegnate sui sigilli antichi, già dal 1900 a.C. avevano serpenti che promanavano dal loro corpo, non solo perché erano guardiane di luoghi e fonti d’acqua remote, ma erano anche le chimere che solcavano i cieli e trainavano i carri degli dèi della tempesta. In alcuni sigilli dell’Età del Bronzo le troviamo a fiancheggiare l’albero sacro all’incirca nel periodo tra l’equinozio d’autunno e il solstizio d’inverno, quando le giornate si accorciano, e luce e buio si equivalgono nel mezzo della stagione piovosa. Il momento più buio è anche il più umido e fecondo, e perciò il più chimerico, come ricorda ancora oggi la costellazione invernale del Capricorno, nata per la prima volta in Mesopotamia. Ecco il nuovo Saturno, un dio ibrido con la coda anfibia. Il demiurgo è un ibrido, realizzò Kubin, e già si affaccia l’Età del Capricorno dal futuro di 2000 anni.
Certo i sigilli di Cornelio sono più evocativi dei sette sigilli apposti al libro dell’Apocalisse, ma è sempre un Agnello dai sette occhi e dalle sette corna a doverli rompere. Curioso che nessun buon cristiano abbia mai considerato come alla fine dei tempi il Cristo non sia più umano. Perciò non sorprende che nello spasmo cantato dalla profetica oca Anser si annuncia: «Ma dell’uomo resterà poco» coi morti «esposti alla pioggia/ che intempera e dissigilla». La crisi climatica in fondo è anch’essa un rivolgersi di ecosistemi. «È ancora troppo umana/ questa umana rivoluzione». Va bene rovesciare i governi come rovesciamo le geografie, ma poi scopriamo all’improvviso che i canti delle balene si sono fatti sordi. Gli sterminati, i profughi e i perseguitati vengono ridotti ad animali da macello dai carnefici che si professano gli unici umani. Ancora più crudo diventa allora il processo degli animali alla luce di questo secolo, con Volpe che realizza «Abbiamo perso il processo», ma il rinnovarsi e l’esaurirsi dei cicli storici fa sì che «Non era perso davvero», perché se da un lato «bufera non fa caso» e devasta ogni cosa, non bisogna pretendere spiegazioni, e quindi la possibilità d’esistere, «a quanto non diventerà mai epoca».
Come le sfingi che fiancheggiano l’albero della vita, così in questo clima cresce l’Edera, pianta dionisiaca, che si arrampica tracciando un nuovo corso del tempo. Non più prima o dopo Cristo, prima o dopo l’Ejira di Maometto, ma un tempo inscritto lungo gli steli della pianta, come gli antichi egizi usavano contare i mesi seguendo la crescita delle palme da dattero. L’Edera avvolge Scantaocchio, ribellatore eroico, lo rinnova per la seconda volta e lo sparpaglia, inaugura un altro evo. Dopo l’eclisse, Bruna è la più giovane delle Mammane, che dona un nuovo computo del tempo nella successione delle malerbe, da cui l’Edera proclama hölderlinianamente «Ciò che estingue/ può anche salvare». Ed è qui, nel centro della bufera, dopo la bufera, che il fuoco continua ad ardere, da cui fiotta quella che la mercuriale Lepre chiama «una verità non temprata», ciò che crescerà imberbe.
Alessandro Mazzi
* * *

* * *
© Fotografia di proprietà dell’autore.