“Die geister, ovvero delle larve”
Su Larvae di Diego Riccobene
“E la mia Morte, indossala / qual nero corollato / tuo velo sul lunario, / che vissi già morendo.”[I].
[…]
L’importanza di affrontare criticamente una tal raccolta è che l’opera di Riccobene richiede una espiazione fatale per essere compresa; rectius: è necessario un castigo magistrale al di là di ogni comprensione, e un’imputazione formulata senza capi di accusa rivolta al lettore, che si dovrà ritenere senz’altro il destinatario di un supplizio la cui conclusione non coincide in nessun modo con il suo termine.
Sia nostra benvenuta ogni eccezione ed opposizione ideologica, di scienza e di coscienza, e mai si dica il contrario – purché la tesi proposta sia tale; e non di meno, principiando la pagina critica, e sezionando la carcassa del libro, non si può ignorare la cura formale e lo studio abissale del lessema in Larvae.
Per questo è fondamentale sottolineare sin da principio che la parola di Riccobene – collegando la presente dissertazione a quelle in prefazione e postfazione del precedente testo del medesimo (Ballate nere, italic, 2021) – rinnova e l’erudizione, e l’urgenza del canto medesimo di cui si fa medium, seppur si dia in misura meno affine alla volontà di rispettare gli argini formali dei dettami barocco-ottocenteschi che informano lo stile peculiare del nostro.
Infatti si noterà spesso, a tal proposito, il lamentoso ritmo giambico cedere il passo all’accostamento metrico ibrido, più fluido perfino, dato dall’abbinare e meticciare l’andamento sacralizzante del dattilo, a quello ben più lugubre dell’anapestico su tutti, quasi de-crisalizzando da una regola assunta ex voto.
Compendiando queste variazioni compositive, e ben consci di star redigendo una riga che taluno definirebbe scolastica, è assai realistico poter asserire che il verso assuma una connotazione ben più personale, accolita, e soprattutto ancillare al significativo del dire fondato.
“Ogni parola è una parola di evocazione. A seconda dello spirito che chiama – uno spirito appare”[III]: e pur in Larvae (omen nomen) assistiamo ad una lingua che enuclea la capacità di rivendicare a sé il ruolo plastico, ctonio e ritualistico, della poesia che ex-voca con il semantema che in primo è cultura e tradizione; così come, secondariamente, si tinge del sangue e si ciba del corpo così cultualmente immolata.
Il risultato ultimo è un’opera pregna di sacertas[IV], istoriata ad arte e produttiva di una phronesis la cui ragione è scrittura che si sostanzia ed evolve negli interstizi sapienziali della parola, e del suo utilizzo; e perciò, in piena osmosi tra la figura della narrazione e del narrato, il senso ultimo del testo non potrà essere il fare retorico, opacizzante e confusorio in una icona che, in ultima istanza, rimane lettera morta.
Ma è invece nel simbolo (forse anche nella ri-semantizzazione di questo nel simbolico) che Riccobene redime il senso ultimo, abissale, del poiein; e recupera il valore più prossimo al primordio istintivo, in cui ogni vocabolo si incrina ed approfondisce il senso della ricerca innestata nella parola, e non adagiata su di questa.
In un certo modo si potrebbe riflettere che ogni testo di Larve tenda alla moltiplicazione del fine teleologico nel proprio farsi-poesia, tant’è che la riflessione dal carattere spiccatamente funerario si rivolge ad un ragionamento che, piuttosto di consegnare all’esistenza una nominazione apodittica, si rivolge ad una molteplicità di attanti e di attori – spesso senza identificarli propriamente.
Anzi: la posa satiresca dell’autore investe di dubbi e provocazioni la pagina, per istigare subdolamente il lettore tacitando ogni altra verità ed azione compiuta al di fuori di quanto fondato nell’opera.
A tal proposito, non sarebbe neanche corretto tacitare il paradosso in cui così, e per una seconda volta, Riccobene ci rigetta: un nuovo fondamento di lirismo, ed una rinnovata modalità riflessiva ed espressiva della poesia ego riferita – e, di conseguenza, dell’io poetante – di cui sarà detto più ampiamente in seguito.
Ad ora si dimostra necessario vergare determinate tematiche teoriche, propedeutiche a questo argomento, perché la composizione richiede un’estrema sospensione dell’incredulità da parte del lettore affinché questo sia convogliato nella partecipazione al testo, alla straniante personificazione dell’astratto, alla situazionalità metaforica/analogica della strumentazione della volontà comunicativa, alla discesa infera accolta dalla sequenza ritmica eterogenea e dalla sintassi articolata e sostanziale dell’autore.
Pertanto il fenomeno di scavo iniziato in Ballate nere qui alligna e seguita – o meglio, il canto del nostro procede nell’indagine di catabasi iniziata in precedenza, così come il verme che interra per poter essere catafratto nella propria crisalide — fiottando una voce roca dal gorgo che conferma sia lo studio (etimologicamente inteso) pregresso, sia la destinazione semantica chiaramente identificabile del nostro.
In effetti il lavorio di escavazione di Riccobene sembra muoversi diacronicamente: infatti questo testo si pone senza dubbio in continuità con quanto composto in precedenza, ma marcia altresì a ritroso nel tempo, e sincronicamente con il senso delle costanti e dei terrori dell’antropocene più reconditi.
Larvae è un canto in illo tempore, una poiesis intermediale di natura diacronica[V]: nasce desquamando la maschera pseudo-rituale come radice interstiziale di tutto l’arcano che è il poetare; ed il tanto si traduce non come artificio ed artigianato, bensì come l’essere-posto-assieme, il nato-morto la di cui genesi è irrecuperabilmente perduta.
La conseguenza più vicina alla razionalità, sia ben chiaro, è che ogni ricostruzione di indagine si traduce – in sede critica, almeno – col muovere il passo nell’ineffabile, nell’indetto, e nell’indicibile; come le fibre del tessuto connettivo che si interpone tra gli elementi cellulari di un organo parenchimatoso, e nascono da una matrice per congiungere ed unificare le due entità separate di esistenza ed in-esistenza.
E qui l’analisi non concede altro che la cristallizzazione del ruolo del dire poetico: la poesia è compito assoluto, e severissimo; ed ha da incarnare lo spirito del proprio tempo, e qualsiasi valenza qualitativa questo comporti.
Coerentemente a questo, sin dalle prime battute del testo, è identificabile quel rapporto che il poeta adegua come mezzo al paradigma scio-excrucior – ricordando, ma con la dignità che manca all’esempio, un giardino degli ulivi ed un certo calice amaro, con la condanna a berlo sin l’ultima goccia, tacendo e soffrendo, aggricciando il volto nell’ingollarlo.
Infatti l’anima lirica, profana e sorgiva, del verso non si risparmia di materiare un clima irridente, intimidatorio persino, nel suo serpeggiare endecasillabico; e non può che afferire infine uno stato di derisoria alterazione, e di scollatura massima dal soggetto poetico (inteso classicamente, dove la parola “io” concretizza anche il soggetto scrivente tramite un collegamento psicologico inscalfibile).
Eppure, e sembra ragionevole farlo (avendo ben presente la lezione dell’opera prima firmata dal poeta), non ci è dato né di escludere che i poli diametralmente opposti si somiglino a tal punto da fondersi, né di sussumere che l’autore intenda mostrare, celandolo a modo, come l’afflato mistico della poesia non sia così distante dal concetto simbolico della stessa — posto che, per addivenire alla consapevolezza di questo, sia necessario scinderlo diabolicamente.
La gloxa di Riccobene scivola salivosa per una lingua che è morta, e che lo è necessariamente; tanto che il suo poieo nasce nella morte – o meglio nasce morto, come parimenti deceduto è colui che narra: il soggetto lirico che porta in sé il racconto in prima persona, per estrinsecarlo a noi lettori.
Seppur questo argomento richieda altri, e più ampi, lidi per poter essere espletato in maniera convincente potremmo già da ora, in via speculativa e tutt’altro che completa, coagulare una sintesi teorica per cui supporre che siano due i moti intrinseci del fenomeno lirico attuale – ben consci di star producendo una riflessione che, sia detto per sommi capi e non senza una certa aria di arroganza, riteniamo come ammissibile stanti il nichilismo circostanziale ed il relativismo di comodo che pervadono la natura intima degli ego a popolare il palcoscenico dell’esistenza mondana e quotidiana, soprattutto letteraria.
Il primo è quello che prevede un “ego scribens” che, partendo dalla natura participiale, non sottende nessuna particolare accezione al termine se non il fatto che lo scrivente è in procinto di scrivere.
Ne consegue, di qui, una scrittura sicuramente ispirata (quasi fosse sotto dettatura) il di cui effluvio materiale, tuttavia, non si può che considerare fragile e frangibile in quanto tale; e per le ragioni più ovvie, del resto: essendo di nascita obbligata, e spesso per candida ammissione di chi la produce, quanto si esperisce sul foglio conserva una natura etica, perché strettamente legata all’ego che l’ha prodotta, e quindi incriticabile proprio in forza di una genesi necessaria, ispirata alla necessità, e quindi assunta dallo stesso autore in modo acritico – nella medesima misura in cui sia affidata al lettore, che dovrà accettarla senz’altro.
D’altra parte, potremmo contrapporre il concetto di “ego scriptor”, il quale – come tutti i sostantivi di questa schiatta in latino, o quasi – evoca nel lettore l’idea di un soggetto che compia qualcosa con volontà, consapevolezza, ed intento creativo: tutti elementi irretiti da uno sforzo tonico, e da considerarsi come preordinati a quanto si sta attuando.
Non ci sembra sbagliato dire che, in tal contesto, la scrittura poetica che ne nasce potrebbe addirittura assumere il connotato di artificiale ed artato, avendo ben presente il sentore dal risultato sintetico di posa come atto-prodotto che passa, e viene affidato, al lettore.
Il lirismo di Riccobene si innesta mediale (di mezzo, se preferibile) tra questi due, e vorremmo definirlo “creaturale”, non fosse che tale dizione si ricavi in via negativa dalle precedenti: questo perché non si rinvengono tracce di mera dettatura sic et simpliciter; né esiste una metacognizione ed estroversione di un io che, corpulento e lepido, sieda sopra un altare di retorica ed incensamenti del proprio sé.
Non con una certo imbarazzo viene scritto questo; ma, nel caso di Riccobene, non sovviene immediata la riflessione che sia una figura lirica identificabile semanticamente ed in concreto come quel soggetto riferito a quella data parola, o connotate esclusivamente di una brillantezza che, alla luce del testo complesso, non si spiega altrimenti – si pensi alla sola coerenza della struttura interna ed esterna dell’opera per provare quanto detto.
D’altronde, lo stesso può dirsi della seconda ipotesi: non vengono recuperate delle strutture retoriche apologetiche, né atteggiamenti caratterizzati da una vistosa ricerca dell’effetto, ovvero al limite del sensazionalismo, nelle righe dell’autore.
La profonda audizione della materia nel nostro abbisogna talora di chinarsi in terra fino alla bocca del cadavere per auscultarne qualsiasi singulto, anche il minimo refolo di respiro; mentre, in altri componimenti, sembra che sia il fantasma, o il Genio in sé a sussurrare parole di discordia e di rovina al poeta: il che si traduce nella dazione alla vita di una creatura come estensione d’estro e di talento del proprio creatore, che a sua volta ha ricevuto istruzioni da vie oscure di cui è impossibile determinare una genesi precisa.
E, a dir di questa linea, tale congettura è perfettamente connessa alla natura più esoterica del testo; tanto che si verifica una irrecuperabile scissione tra creazione e creante, ed una oscurata dicotomia tra creatura e creatore a fondamento dell’intero corpus di poesie.
Quindi: se la lingua di Larvae nasce già morta, se l’opera in quanto tale è ciò che non è, e se l’ontologia paradossale invera questo spettro iscritto alla parola, non possiamo disconoscere come poeta e poesia siano legati strettamente nella misura in cui il primo sia limitato alla funzione di essere medium, e cioè colui che è tanto sé stesso quanto l’altro.
Ed in tal caso sia quest’alterità, da sopra calata o sorgente dall’imo come un verme, non fa differenza in una dimensione in cui non esistano coordinate geografiche e di giudizio rilevanti: che sia la creaturalità di Larvae, dunque, ed il modus – ed anche l’unico riferimento ammesso, nella ventraia di ambiguità sconsacranti e dissacrate da Riccobene – per raggiungere un altro livello di assimilazione del suo verso ci sembra l’unica cosa da ritenersi vera, almeno quanto lo è affermare che questi versi richiedano un ultimo sacrificio per essere assorbiti.
È l’opera stessa a richiedere una metanoia per darsi, nei termini in cui essa desidera farlo; perché lo scritto si radica nel mistero in primo, ed ogni ulteriore esegesi riversa per forza di cose nella mistificazione, e nell’artificialità di una spiegazione che, in fondo, è superflua – od anche non aderente allo scritto stesso, ed affoga nel tentativo di coagulare un intendimento razionale condivisibile.
Concludendo, tutti i punti sinora vergati declinano stilisticamente una rigorosissima coerenza d’intenti col significativo del testo; e, più concretamente, la scelta del lessema quanto più pregno (nel caso di specie, abissando nell’aulico) e foriero sugnoso di oracolarità, al limite del profetico.
L’esito di tutto questo è una narrazione che tanto umilia e ridicolizza ogni tentativo di cognizione da parte di una coscienza che non si dimostri adeguata, quanto concreta un dettato che è sia sarcofago che salma – quindi, spirto viridescente di quanto celato nel sema nella sua emergenza primale, la cui stesura si espone vedendo e non vedendo al contempo entro la divinazione che stratifica, verso su verso.
Carlo Ragliani
* * *
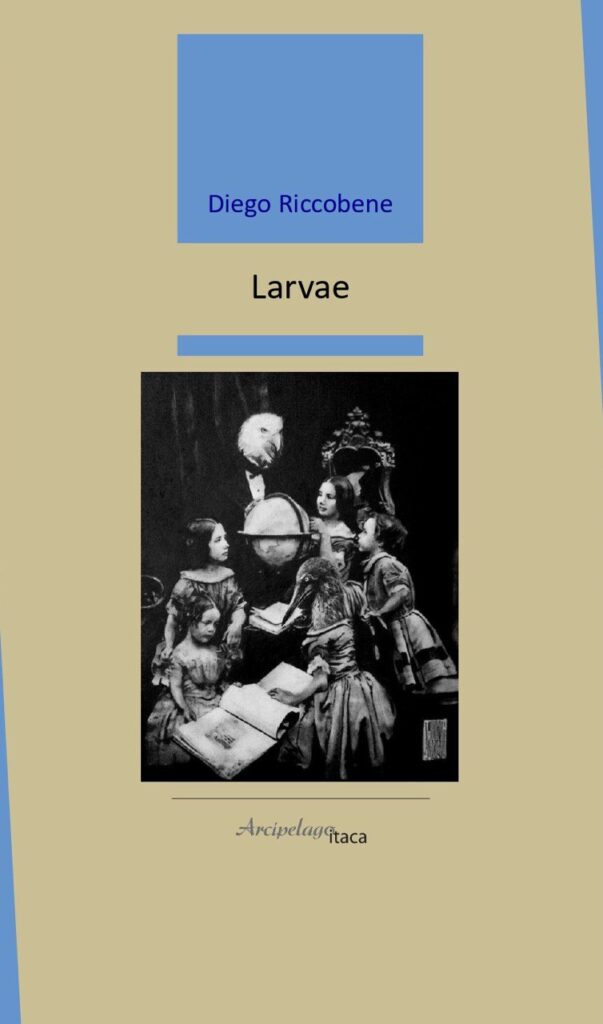
* * *
Diego Riccobene (Alba, 1981) vive in provincia di Cuneo. È laureato in Filologia Moderna presso l’Università degli Studi di Torino; è poeta, docente, musicista. Suoi scritti e interventi sono apparsi su antologie, webzine e riviste quali Atelier, Menabò, Poesia del Nostro Tempo, Critica Impura, Inverso, Versante Ripido, Laboratori Poesia, Pannunzio magazine, Neutopia, l’Estroverso. Alcuni suoi componimenti sono stati tradotti in lingua spagnola dal Centro Cultural Tina Modotti. Collabora con la redazione di Menabò online. Ha pubblicato Ballate nere (Italic Pequod, 2021), silloge segnalata in occasione del Premio Lorenzo Montano 2022 – sezione opere edite. A questa fa seguito il poemetto “Synagoga” (Fallone editore, 2023).
Carlo Ragliani (Monselice, 1992), laureato in giurisprudenza presso l’ateneo rodigino dell’università di Ferrara. È redattore in Atelier Cartaceo, e caporedattore in Atelier Online. Ha pubblicato Lo stigma (italic, 2019).
* * *
In copertina del testo: “Sapienza”, di Mirko Andreoli
* * *
[I] Dalla sezione “Inni” del testo.
[III] Novalis, Frammenti, (BUR, 1976), introduzione di Enzo Paci e traduzione di Ervino Pocar.
[IV] Si badi bene che il termine desidera appropriarsi del significato etimologico, e della connotazione giuridica propri: nella lingua latina “sacer” era una vox media con il significato, a seconda del contesto, di “sacro” o “maledetto”. In tal senso, il termine è usato sulla base del particolare significato di “maledetto, colpito da un influsso negativo da parte degli dèi”. Validissimo a tal proposito sembra ricordare che, nel diritto romano arcaico, con “sacertas” si definisce la condizione del soggetto indetto “homo sacer”: colui che, per aver commesso un delitto contri numi o la compagine dello Stato, era consacrato alla divinità, e cioè abbandonato alla vendetta degli dèi ed espulso dal gruppo sociale. Il colpevole, cui erano confiscati i beni (“consecratio capitis et bonorum”, pronunciata secondo il particolare rituale della “detestatio”), poteva essere ucciso o fatto schiavo da parte di chiunque, anche in pubblica piazza, con garanzia di impunità. In breve, la “sacertas” era una sanzione a carattere giuridico-religioso inflitta a colui che determinava, con la propria condotta, un’infrazione della “pax deorum”; e, giuridicamente, comportava la perdita della protezione che la civitas garantiva ad ogni cittadino. A tal proposito, la comminazione del tanto seguitava alla pronuncia del “sacer esto” (“sia maledetto”), formula penale con cui si consacrava qualcuno agli dèi inferi (formula presente nelle leggi delle XII Tavole).
[V] Come già è stato detto nell’intervento “La morte è osceno rospo che s’ammoglia – Diego Riccobene”, apparso in data 12.XI.2021 nel litblog Laboratori Poesia.



