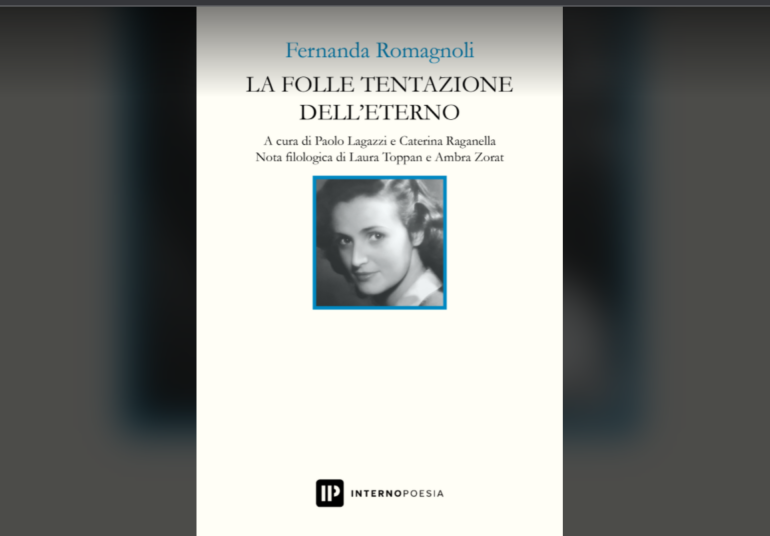Fernanda Romagnoli, nata nel 1916 a Roma da una famiglia piccoloborghese, si diplomò alle magistrali e poi in pianoforte all’Accademia di Santa Cecilia. Sposatasi con Vittorio Raganella, militare di carriera, visse sempre accanto a lui e alla loro unica figlia Caterina lavorando come maestra elementare. Gravemente malata per molti anni, morì nel 1986. Le sue poesie, pubblicate tra il 1943 e il 1980 in sole quattro raccolte (Capriccio, Berretto rosso, Confiteor e Il tredicesimo invitato), sono testi altamente drammatici, segnati da un’intensità visionaria, da una passione mistica e tragica unica nel Novecento italiano. Sebbene poeti come Carlo Betocchi, Attilio Bertolucci e Vittorio Sereni abbiano creduto in lei e si siano adoperati per promuoverne l’opera, la sua grandezza non è stata ancora riconosciuta davvero. La folle tentazione dell’eterno, la più ampia scelta dei suoi versi finora apparsa in Italia, vuole contrastare l’indifferenza che per troppo tempo ha avvolto questa creatrice di liriche potenti e perfette, vibranti di dolore e arse da un immenso pathos metafisico, percorse dai venti ingovernabili dello spirito e innervate da un’inesausta, tormentosa ricerca dell’assoluto.
*
LA FOLLE TENTAZIONE DELL’ETERNO di Fernanda Romagnoli, a c. di Paolo Lagazzi, Caterina Raganella (InternoPoesia 2022).
Preghiera
Ma non con la mia anima tiranna
Ti pregherò, Signore.
Con questo corpo
nutrito dalle briciole cadute
all’orgoglio dell’anima, con questo
portatore di pena
con questo muratore senza tetto
con questo domatore di demòni
con questo letto di vene
con questa miniera accecata
che invoca barlumi,
con questo informe mugolìo di fiamma
che tenta canzoni:
col corpo mio Ti pregherò, Signore.
*
Stigmata
Qui dunque fui bambina. Alla marina
crescevo accanto: l’anima digiuna
d’ogni perché – famelica altrettanto.
Gigli ad oriente, la riva era una spada.
Stupendo sacrilegio imporvi un segno
– l’arco del piede –, premere col viso
la freschezza deposta dalla luna.
Il mare straripava nel sereno
a livello dei cigli. Ah, la bellezza
che pativo, non mia, che mia stringevo
in quel primo singhiozzo di creatura
che s’arrende all’immenso – era già il pegno,
la stigmata che in me sfolgora e dura.
*
Confiteor
A dirmi «madre» provo, a dirmi «sposa».
Solo parole, leste a fuggir via
– ladre – coi vaghi suoni della vita,
coi suoi barlumi. A esistere, in balia
resto d’un nulla, un soffio, che non osa
neppure in sé chiamarsi «poesia».