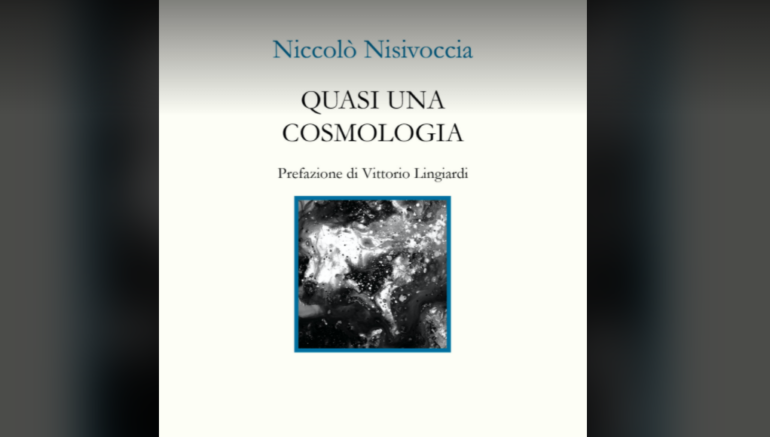Quasi una cosmologia (Interno Libri, 2021), di Niccolò Nisivoccia
Nota di lettura a cura di Davide Morelli
Calvino sceglie la leggerezza e la brevità per sconfiggere «la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo». Si potrebbe aggiungere: per ridurre la complessità del mondo. Il mondo è un poliedro dalle moltissime facce. Leggerezza significa rapidità e riduzione all’essenziale. Come scrive Guicciardini nei Ricordi: “Poco e buono, dice el proverbio”. Come scrive in modo esemplare Lichtenberg in Osservazioni e massime: “Dire molto utilizzando poche parole, non significa scrivere l’articolo e poi abbreviare i periodi, ma dedicarsi molto a quel pensiero e riportare solo la parte migliore, così che il lettore intelligente si accorga da solo ciò che è stato omesso.
In realtà ciò significa: mostrare che si è pensato molto utilizzando il minor numero di parole”. Questo brano di Lichtenberg si addice completamente a Nisivoccia. Ma l’autore, pur dimostrandosi sintetico coi suoi versi aforistici, nella sua sintesi è esauriente, addirittura esaustivo perché tratta molte tematiche, molte problematiche, insomma le peculiarità di noi esseri umani. Nella sua sintesi non vengono mai omessi i passaggi logici, nonostante sia perfettamente conscio della non linearità dell’esistenza e della contraddittorietà del reale. Non manca mai il bersaglio. Ci parla con il cuore in mano della condizione umana senza sentimentalismo, pur mettendo in conto che ogni scrittura è cicatriziale. Vittorio Lingiardi nella prefazione scrive che, leggendo i suoi frammenti poetici, si viene sfiorati da “piccoli miracoli”, e trovo che abbia ragione.
Negli aforismi di Nisivoccia si avverte il rapporto problematico con la verità interiore, che è sempre sfuggente, transitoria. L’autore si dimostra onesto intellettualmente perché non fornisce falsi punti saldi, né dogmi scontati come alcuni sedicenti maestri delle frasi motivazionali e della crescita personale. Secondo gli orientali ogni istante ha la sua verità. Potremmo affermare che ogni uomo ha la sua verità e allo stesso tempo nessuno conosce la verità. La verità interiore muta nel tempo e nello spazio. Certezze che sembravano granitiche ed assolute si sgretolano dopo poco tempo. Quella che in prima battuta ci sembrava una verità inossidabile scopriamo dopo un poco di tempo essere solo una parvenza di verità. Quelle che credevamo delle personali piccole verità talvolta ci accorgiamo non essere altro che luoghi comuni. Alcune verità facciamo fatica a disvelarle, altre le occultiamo volontariamente perché ci fanno troppo male. La verità in questo libro oltre ad essere proteiforme è puntiforme.
L’autore ci mostra i suoi atomi psichici ed esistenziali, come fanno secondo Debenedetti i migliori autori del Novecento. Chi è religioso può affidarsi solo alla verità rivelata. La religiosità dell’autore a mio avviso non ha niente a che vedere con il misticismo, ma è qualcosa che resta sottotraccia e spesso permea la scrittura. La sua spiritualità non consiglia, non ammonisce né consola, ma descrive la condizione umana con partecipazione e pietà. La nostra voce interiore, la nostra la coscienza, insomma, talvolta ci presenta il conto. Ci mostra le nostre zone morte ed i nostri lati oscuri. Pensare, ragionare tra sé e sé, interagire con sé stessi, parlare a tutti, raccogliersi restando indifferente al rumore molesto del mondo: questo è scrivere, per Nisivoccia.
L’autore evita il pleonasmo e la perifrasi. Riflette senza essere mai sistematico. Ha il pregio di essere asistematico, pur non essendo irrazionalista. Avverte sia la crisi del soggetto che la crisi della relazione tra soggetto ed oggetto. Per Merleau-Ponty noi percepiamo e conosciamo la realtà tramite il corpo. Nisivoccia richiama implicitamente il filosofo francese. Come scriveva quest’ultimo: “Riflettere autenticamente significa darsi a sé stesso, non come una soggettività oziosa e recondita, ma come ciò che si identifica con la mia presenza nel mondo e con gli altri come io la realizzo adesso. Io sono come mi vedo, un campo intersoggettivo, non malgrado il mio corpo e la mia storia, ma perché io sono questo corpo e questa situazione storica per mezzo di essi”. Insomma, il corpo è il tramite fondamentale, lo strumento precipuo della nostra conoscenza. Come dicevano gli antichi “nulla è nell’intelletto che non era prima nei sensi”. Non saremmo niente senza le nostre sensazioni e percezioni. In fondo le radiazioni degli oggetti per essere conosciute devono tradursi in reazioni fotochimiche nei nostri recettori. Nisivoccia indaga anche l’io-corpo-mondo come datità, come fonte di selezione, riduzione, elaborazione, rielaborazione degli stimoli, che divengono informazioni. Parafrasando Wittgenstein potremmo affermare che i limiti del mio corpo sono i limiti del mio mondo. Secondo la psicologia contemporanea il corpo è il nostro “primo oggetto psichico”. Questo è quanto vuole esprimere Nisivoccia, e lo fa egregiamente. Tuttavia, occorre rilevare che in quest’epoca più che la nostra corporeità pare contare il nostro apparire. L’apparenza per molti equivale all’essenza. Il corpo è al contempo croce e delizia.
Ad esempio durante la pandemia c’è stato un aumento del 30% delle operazioni di chirurgia estetica. Le persone non sono soddisfatte di come appaiono in smart working, via cam, eccetera eccetera. La preoccupazione più assillante riguarda il cosiddetto io corporeo più superficiale. La dismorfofobia aumenta vertiginosamente in tutte le fasce di età. Il body shaming è sempre più diffuso. Siamo tutti o quasi schiavi dell’apparire e dell’estetica del nostro involucro. Difficilmente riusciamo ad amare il nostro corpo, ad esserne soddisfatti. Spesso taluni, per ritornare a stare bene con sé stessi, devono cambiare il loro aspetto. Ma la ragione di ciò ad onor del vero non è dovuta al corpo stesso, ma più che altro alla nostra fragilità psicologica. Siamo prigionieri del nostro io corporeo più superficiale. Nisivoccia comunque tratta il rapporto io-corpo-mondo in modo gnoseologico, forse addirittura ontologico. Trattare questa relazione è un modo per sviscerare la conoscenza e allo stesso tempo rimanere ancorato alla realtà. Come scrive lo psicologo Walter Gerbino, percepire significa sostanzialmente avere una rappresentazione fisica del mondo e al contempo cogliere, afferrare il reale.
Nisivoccia percepisce il mondo in tutti e due questi significati. Percepire significa integrare i cinque sensi. I grandi artisti e le persone più spirituali sono tali anche perché si sanno avvalere della loro fisicità. Ma non è solo questo. Moravia scrisse, ne L’uomo come fine: “Siamo uomini e non automi, mangiamo carne e non concetti, beviamo vino e non sillogismi, facciamo l’amore con individui dell’altro sesso e non con la dialettica”. È vano e deleterio staccarsi troppo da terra, fare troppe astrazioni, senza considerare i nostri limiti fisici intrinseci. Secondo la mistica cristiana, secondo San Giovanni e secondo Santa Caterina da Siena il mondo, la carne, il demonio sono i tre nemici dell’anima. Ma Nisivoccia si relaziona al reale tramite la corporeità non secondo questa accezione negativa, non mortifica l’aldiqua per l’aldilà, ma cerca una chiave di volta tesa ad una vera filosofia pratica, senza perdersi nella speculazione vacua, nella filosofia teoretica che perde di vista il nocciolo della questione. Nisivoccia ha scritto un altro libro sul vuoto dove parla anche del corpo, mettendo in relazione questi due temi.
Il vuoto interiore non è relativo perché mancano i termini di paragone.
È indefinito ed indefinibile. Pensiamo che il nostro animo sia concavo, sia un recipiente. Usiamo le espressioni “colmare un vuoto” oppure “vuoto incolmabile”. Ma non ne conosciamo la capienza. Non sappiamo i limiti dell’anima, né se esiste. Forse la nostra psiche è un pozzo senza fondo. Per l’esattezza non sappiamo se dal vuoto interiore nasca il disagio esistenziale, se sia viceversa o se semplicemente vuoto interiore e disagio esistenziale siano la stessa cosa e si equivalgano totalmente. Talvolta ci si riferisca al vuoto interiore per metaforizzare il vuoto cosmico. Altre volte succede viceversa. Nelle psicopatologie, nello Zen, nella meditazione si parla tanto di vuoto mentale. Ad ogni modo una cosa pare certa: Nisivoccia arriva a toccare qualcosa in profondità, indagando la relazione tra la nostra fisicità ed il nostro animo insondabile.
Stanno scomparendo le comunità e la comunicazione autentica. L’individuo è atomizzato. La massa è anonima. Il potere sembra così neutro da apparire impalpabile. Su tutto prevale l’immagine, la cupidigia, il culto del denaro ed un’etica del lavoro che, se analizzata, risulta riprovevole cristianamente. Questa è la civiltà dell’immagine e le masse sono idolatre, solo pochi solitari hanno un atteggiamento critico e trovano la forza per essere iconoclasti. L’uomo contemporaneo non sa come utilizzare la libertà. Una libertà inaudita rispetto ai secoli precedenti, ma in fin dei conti una libertà apparente. Tutto ciò è sottinteso in Nisivoccia. L’uomo contemporaneo non ha più la vitalità sufficiente per vivere il dionisiaco, né la saggezza per giungere all’apollineo. Sono i paradossi della modernità. Da considerazioni come queste scaturiscono i frammenti, le intuizioni, a volte il disagio di Nisivoccia:
“Quando il giorno si allunga, trovare te – sulla soglia di ciò che ancora non siamo, di ciò che vogliamo.”
“Dentro una mattina di luce che filtra dalle persiane. Quasi più buio che luce. Fuori, il bosco. È l’età ancora dell’inconsapevolezza, della pura presenza, di un gesto, di un tocco. È l’età in cui la pura presenza, un gesto, un tocco ancora bastano, ancora non hanno bisogno di altro. Avverti una presenza, vieni sfiorato da una carezza. È l’inizio di una memoria, è l’inizio di una storia.”
“Ciò che testimonia la nostra fedeltà al contempo la esige: verità sommerse che il vivere, nel suo traffico quotidiano, dimentica e cela; volti nell’ombra, che la vita ci chiama a cercare – e che prima o poi, nel suo aprirsi alla luce, rivela e disvela.”
“Dove si è perso, il senso di ogni singolo gesto compiuto? Un libro appoggiato proprio lì, in questa foto. Un tuo sguardo, un tuo sorriso, una posa. Tutto ciò che hai fatto, nel passato. Dove si sono perse, le cose? Come arrivano, a me – ora e qui, a fare di me quel che sono? Come arriveranno a te, attraverso il tempo, domani? Saranno poco più di niente – un filo di fumo, un sentore, appena un suono?”
Oggi i romanzi sono troppo lunghi per essere letti. Perfino i racconti di Maupassant oggi sono considerati troppo lunghi, ed anche il minimalista e postmoderno Carver, maestro ineguagliabile della short story, non è conosciuto al grande pubblico. Tutti hanno fretta. Buona parte dei lettori sono impazienti e frettolosi. Giungere al punto, arrivare subito al dunque, al conquibus è diventato un imperativo categorico per chi scrive. Oggi molti scrittori si sono adeguati a scrivere aforismi per catturare follower sui social. Ma scrivere poemi in prosa ed aforismi è un’arte che va saputa praticare con talento, tenacia, perseveranza. L’elogio della brevità ha valide ragioni stilistiche, oserei scrivere ontologiche. Non sempre i preliminari sono piacevoli.
Anzi talvolta i preliminari sono un rimandare continuamente il piacere, diventano la mancanza del piacere, del momento topico. Freudianamente certi preliminari sono perversione pura, sono fissazione o regressione. Ad essere troppo prolissi si rischia di tediare a morte i lettori. Essere brevi, incisivi e saper arrivare al nocciolo delle questioni non riesce a molti. Dire molto con poco significa saper selezionare, saper discernere il meglio della propria produzione. Allo stesso modo uno dei rischi della brevità è quello di essere troppo sbrigativi, troppo sciatti. Non è però il caso di quest’ opera. Spesso ai molti che scrivono aforismi difetta la qualità, mentre invece questo libro ne è ben dotato. Gli stessi scrittori di successo spesso scrivono libri di centinaia e centinaia di pagine, che i lettori si affrettano ad acquistare e poi lasciano a intonsi sul comodino o su un ripiano della libreria.
Molti si improvvisano aforisti sui social,o infarciscono libri di descrizioni ossessive e troppo puntigliose, forse inutili. Niccolò Nisivoccia è ben lontano da queste modalità, dimostra di andare controcorrente con un libro leggero ma per niente frivolo, un libro leggero come lo avrebbe inteso Italo Calvino: di questo pregio gli va dato merito. L’autore poi non si improvvisa aforista dell’ultim’ ora. Rientra a pieno diritto nella cerchia dei raffinati aforisti, di quelli che un tempo si chiamavano un poco ampollosamente fini dicitori, senza facili ammiccamenti al lettore.
Il rischio, quando si riduce all’essenziale, è quello di togliere troppo, perfino ciò che è essenziale, scarnificare, spolpare, ridurre tutto ad un torsolo di mela. Le domande sono le seguenti: cosa è veramente prioritario ed essenziale? Cosa invece deve essere tolto e scartato? Qual è la giusta misura? Nisivoccia dimostra di saperlo bene; comprime, sintetizza, ma lo fa con maestria, con efficacia, con grazia. Non toglie le fondamenta del reale. Ma poi non si tratta solo di aforismi. L’autore si muove sul crinale tra aforisma/epigramma e frammento di prosa. Recentemente ci sono stati grandi poeti italiani come la Merini e Zeichen che si sono dedicati all’aforisma. Nisivoccia ci ricorda che l’aforisma è un genere antico, nobile, ingiustamente bistrattato, soprattutto oggi da chi lo pratica superficialmente. Ippocrate scriveva aforismi ed i sūtra erano aforismi. Secondo l’Atlante di filosofia della Hoepli gli aforismi devono essere brevi, molto concentrati nel senso di densi di significato, devono esporre paradossi, devono ricorrere ad immagini. I frammenti di Nisivoccia hanno tutte queste caratteristiche. Per alcuni il paradosso è un cortocircuito della logica, per Roberto Gervaso è una verità controcorrente, per Oddifreddi è una verità rovesciata, capovolta. Nisivoccia si confronta qui con i paradossi esistenziali e metafisici. Ma esiste anche l’amore, trattato qui con tatto e discrezione:
“Il tuo confine, il confine fra noi – fra la mia realtà e la tua fantasia. Fra il rimanere e l’andarsene via.”
“Confusi nella luce e nell’ombra. I miei sensi confusi nei tuoi, i tuoi nei miei.”
“Toccare il tuo corpo, che tutti i corpi raduna, che tutti i corpi contiene. Toccare il tuo corpo, e toccare l’essenza.”
L’autore si rifà al poème en prose, ma la sua scrittura è più gnomica. Questi testi sono caratterizzati senza ombra di dubbio dalla loro letterarietà. L’autore non ricerca slittamenti semantici, non ricerca nuove semantizzazioni, non ricerca la mitopoiesi, ma cerca leggi generali, verità interiori parziali sotto forma di aforismi dalla spiccata vocazione lirica; inoltre, riprendendo la riflessione leopardiana secondo la quale la poesia moderna si è fatta “filosofia del dolore”, si può osservare la presenza di pathos, in questi frammenti, che in ogni caso non cadono mai nel flusso di coscienza né in stereotipi espressionisti. Un’opera, questa, che rientra a tutti gli effetti nel genere poetico, al di là di valutazioni basate su canoni oggi troppo riduttivi come la metrica. Non è più tempo di rigorismi, quanto a distinzione in generi secondo compartimenti stagni… A volte sembra quasi che l’autore, con garbo ed autoironia, voglia presentarci delle sapienti glosse, delle illuminanti note a margine del grande libro della vita. È troppo accorto per finire nel vicolo senza uscita dell’aporia, e il suo linguaggio è troppo consapevole ed appropriato per scadere nell’idioletto, nel crittogramma. Frammento dopo frammento, considerazione dopo considerazione, l’autore mette assieme un libro denso, sostanzioso eppure di agevole lettura. Tutto è ridotto all’essenziale, che non significa ai minimi termini. Non si giunge mai al grado zero della scrittura, la quale allo stesso tempo non è mai ornamentale, esornativa. Non si dilunga mai troppo in digressioni e descrizioni. Esistono a riguardo due scuole di pensiero. Secondo alcuni la descrizione è qualcosa che può essere omesso, mentre per Barthes è una parte irrinunciabile della prosa. L’autore non lascia niente al caso, ma propende per la prima posizione.
“Il corpo, al centro della scena: in ogni sua gioia, in ogni sua pena.”
“Il corpo – che cerca comunioni, non solitudine.”
“Ricordare, attraverso i sensi, ciò che non abbiamo mai saputo.”
“Capire le cose, pur senza capirne la causa.”
È doveroso a mio avviso aprire una parentesi. Chi propende a scrivere di sé rischia di “fare” fisiologia, di compiere puro e semplice soggettivismo. Se non riesce a dissolvere la propria individualità resteranno solo le descrizioni minute degli urti con gli altri, dei fardelli del proprio grigiore esistenziale. Interessano poco o niente le strategie difensive o offensive nei confronti della vita, se il mondo privato non assurge ad una visione sovraindividuale.
Non si tratta certo di attuare una simbiosi tra letteratura e vita, dato che questi sono tentativi il più delle volte vani, che fanno rinunciare alla pienezza dell’esistenza e inducono alla creazione di mondi fittizi, di surrogati della vita vera. Se un tempo lo strutturalismo metteva ai margini la dimensione privata degli autori, oggi si riscontra una moltitudine di piagnistei, un intimismo generale, che rivela la massificazione e l’appiattimento totale delle personalità. Se è vero che ogni esistenza è unica ed irripetibile, è altrettanto vero che oggi pochi sanno essere veramente originali e sanno esplicitare la propria vena creativa. In Nisivoccia l’introspezione psicologica riesce a spalancare ancora nuovi orizzonti, a descrivere una identità fluida; egli procede con circospezione dal poco noto al molto ignoto, misurandosi con l’incommensurabile, con l’instabilità del mondo ed il suo eterno divenire. Lui sa che cosa del mondo – anche la più insignificante apparentemente – può divenire metafora. Il mondo può apparire sia un ammasso informe che una selva di simboli da cui non ci si riesce a districare. Per la morale il mondo può apparire una Babilonia, per la logica una Babele. Il mondo può risultare enigmatico, la sua fisionomia sfuggente e le verità di ieri il giorno dopo possono apparire antiquate e fuorvianti. L’autore comunque non sceglie l’io o il mondo, ma riesce molto bene a descrivere la relazione – sempre più caleidoscopica – tra io e mondo. Nel fare questo elabora uno sguardo autentico e originale sul mondo.
Illustri filosofi hanno cercato di rintracciare la causa principale della crisi della modernità. Freud scrisse del “disagio della civiltà”, Max Weber della “gabbia di acciaio”. Per Nietzsche l’origine di tutti i mali è il nichilismo, per i marxisti il plusvalore e i mezzi di produzione, per i cattolici la secolarizzazione, per gli esistenzialisti l’angoscia della scelta. Per Husserl il mancato ritorno al mondo della vita, per Mounier l’individualismo, per Dewey il fatto che il mondo sia aleatorio e rischioso. Per Niezsche Dio è morto, gli strutturalisti invece annunciano la morte dell’uomo. Ma forse non esiste una sola causa alla crisi della modernità. Forse le cause sono molte. La letteratura italiana del’900 ha perseguito la sfida al labirinto gnoseologico-culturale di cui parlò Calvino, una sfida difficile, ma allo stesso tempo anche affascinante. La letteratura italiana del’900, proprio come uno dei personaggi più famosi di Pirandello, il fu Mattia Pascal, ha dovuto rischiare più volte il proprio patrimonio (in questo caso la propria tradizione) come chi gioca al casinò, darsi per morta e cambiare identità per ritrovarsi e ritrovare il senso di un mondo sempre più arcano e sfuggente. Ebbene, Nisivoccia non cerca di dare una spiegazione, di trovare le cause, forse perché finirebbe in un regresso infinito, ma mostra adeguatamente la crisi dell’uomo contemporaneo. Di tutto ciò gli va dato atto. Gli atomi sono fatti soprattutto di vuoto, ma i nuclei e gli elettroni sono solidi, e sono tenuti insieme dalla forza elettromagnetica. Dopo aver trattato in un precedente libro del vuoto, Niccolò Nisivoccia si occupa con questo delle particelle esistenziali, metafisiche sotto forma di aforismi. Forse vuole dirci che le regole che governano il microcosmo sono le stesse che governano il cosmo. È per tutte queste ragioni che consiglio vivamente di leggere questo libro.