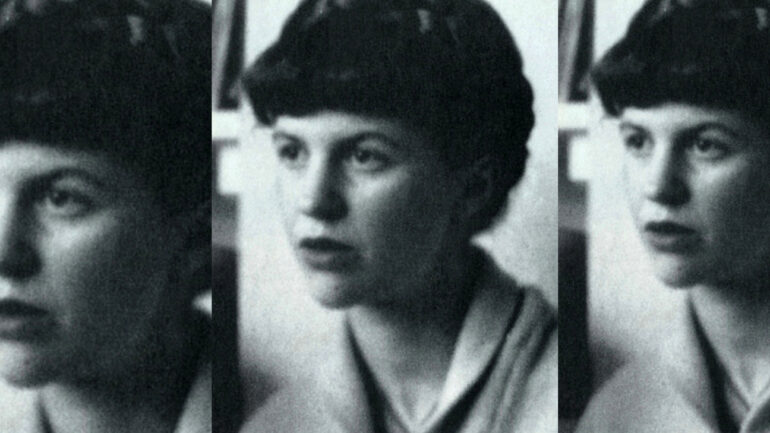In una casa nei pressi di Boston, intorno al 1934, una bambina che ha appena iniziato a camminare accoglie ogni avventore piangendo: «Ti voglio bene! Ti voglio bene!». Mentre la madre imbocca il fratello più piccolo, lei prende il giornale e legge a voce alta tutte le lettere maiuscole. A otto anni danza nel buio vestita di lamé, inseguendo se stessa, annaspando un pochino, «come qualcuno che cerca qualcuno che annega / nell’acqua scura» [1].
La figura dell’Altro, del Rivale, uomo o donna che fosse, ha sempre esercitato su Sylvia Plath un fascino misterioso, continuando a ossessionarla, nella vita così come nella poesia. Non a caso dedicò la tesi di laurea al tema del doppio in Dostoevskij, intitolandola The Magic Mirror.
Cosa rappresentava l’Altro, l’Altra per Sylvia Plath? Probabilmente la parte di sé a cui aveva dovuto rinunciare, quando invece avrebbe voluto essere tutto. «Frustrata? Sì. Perché non posso essere Dio – o la donna uomo universale» annotava sul diario tra i diciotto e i diciannove anni [2], per poi domandarsi per quale motivo non potesse provare vite diverse, quasi fossero vestiti, per scoprire quale le donasse di più. Impossibile non pensare al celebre passaggio contenuto ne La campana di vetro, il suo unico romanzo, in cui la protagonista si immagina ai piedi di un albero di fico, incapace di scegliere quale frutto preferisca, quando ognuno simboleggia un diverso futuro possibile: un marito e dei figli, la celebre poetessa, l’accademica spigliata, la direttrice di una prestigiosa rivista, la campionessa olimpionica, «l’Europa e l’Africa e il Sudamerica, […] Costantin, Socrate, Attila e tutta una schiera di amanti dai nomi bizzarri e dai mestieri anticonvenzionali». Spiega: «Li desideravo tutti allo stesso modo, ma sceglierne uno significava rinunciare per sempre a tutti gli altri» [3].
È per questo che invidia profondamente l’Altro (nelle giuste circostanze, s’intende): per aver scelto una vita diversa dalla sua, per aver colto l’altro fico – non importa se sempre e soltanto uno, non importa con quanta volontà –, impersonando quella parte di specchio che non la riflette, e diventando così una minaccia, un rivale. In quale competizione? Forse nella costante e disperata lotta per accaparrarsi l’amore, la stima, il riconoscimento che Plath avrebbe voluto in maniera totale e che pensava di meritare solo essendo un individuo totale.
Il fratello Warren, la madre, i compagni del college, Anne Sexton, il marito Ted Hughes, la sorella di lui sono solo alcuni dei molteplici volti di cui l‘Antagonista si è servito per incontrarla e affrontarla; tra gli ultimi quello di Assia Wevill, la donna che segnò la fine del suo matrimonio. Così le si rivolge in un passaggio della poesia The Other [4], qui tradotto da me:
[…] È così intrigante la mia vita?
Per questo dilati gli anelli degli occhi?
Per questo le particelle d’aria si staccano?
Non sono particelle, sono globuli.
Avanti, apri la borsetta. Cos’è questa puzza?
È il tuo lavoro a maglia, indaffarato
a contorcersi su se stesso,
sono le tue caramelle appiccicose. […]
In tutta la poesia Plath osserva la «bianca Nike» che ondeggia tra le sue pareti con superiorità e disprezzo, desidera annientarla e sbugiardarla, ma ne riconosce anche il potere ammaliante. Ted Hughes, nel testo Dreamers, proposto sempre in una mia traduzione, a riguardo scrive:
[…] Ti affascinava. […]
Il suo iride grigio inanellato di buio, vagamente innaturale
era un lupo della Foresta Nera, la figlia di una strega
appena uscita dai Grimm.
La coltivasti come in una guerra.
[…]
Chi era quella Lilith degli aborti
intenta a sfiorare i capelli dei tuoi figli
con unghie tigrate? […] [5]
Aleggia un senso di fatalità in queste righe, quasi la figura di quest’incantatrice – a sostegno dell’intreccio bizzarro della nostra dissertazione – non fosse che l’incarnazione della Rivale venuta ancora una volta a chiedere a Plath di saldare il conto con se stessa, tamburellando sul tavolo proprio come il soggetto di The Rival [6] (la madre? La cognata?) composta l’anno precedente:
[…] Mi sveglio in un mausoleo; sei qui,
che tamburelli le dita sul tavolo di marmo, cerchi le sigarette, […]
e muori dalla voglia di dire qualcosa di definitivo. […]
Ma è in Two Sisters of Persephone, del 1956, che il tema del doppio emerge con maggiore chiarezza. In questa poesia Plath evoca l’immagine di due sorelle dal carattere completamente opposto: una intellettuale, sterile, rigida, che passa le giornate chiusa in casa a risolvere problemi matematici, e l’altra piena di vita e di passione, rilucente e bronzea, così fertile da partorire tra l’erba il figlio del sole. Le due fanciulle fanno senza dubbio appello alla dualità della Regina dell’Oltretomba, ma sembrano richiamare anche qualcosa di più profondo, vale a dire un conflitto tra due dimensioni dell’esistenza. Ombra e luce, mente e corpo, controllo e abbandono, sterilità e fertilità – la lotta non è esplicita, ma si manifesta come contrasto simbolico – contrasto che l’autrice avvertiva in primis dentro di sé.
Apicoltrice e donna di città, figlia perfetta e Lady Lazzaro, mangiatrice di uomini e madre accudente, studentessa impeccabile e ragazza spregiudicata, Sylvia Plath è la paladina di tutti coloro che vivono in una perenne (illusoria?) contraddizione. «Se nevrotico vuol dire desiderare contemporaneamente due cose che si escludono a vicenda» scriveva ne La campana di vetro, «allora io sono nevrotica all’ennesima potenza» [7].
È possibile desiderare allo stesso tempo due cose che si escludono a vicenda? O si desidera sempre e soltanto una cosa alla volta, anche se in istanti estremamente ravvicinati? E chi ci assicura che i nostri desideri siano davvero incompatibili, e che non ci abbiano solo insegnato a pensarla così? Plath non si è mai accontentata di cogliere un unico fico, di rivestire un unico ruolo, a costo di diventare lei stessa la Rivale da cui avrebbe dovuto guardarsi. L’Altra, che bussava alla sua porta a cadenze regolari, indossando una maschera diversa per ogni occasione, non era, in definitiva, che una parte rinnegata di sé. Non le restava che attendersi, prima o poi si sarebbe raggiunta, come la belva che la incalza in Pursuit: «il passo della pantera è sulle scale, / ora lo sento che sale, che sale», nella traduzione di Anna Ravano [8].
Valentina Furlotti
* * *
NOTE
1 – Ted Hughes, God Help the Wolf after Whom the Dogs Do Not Bark, in Birthday Letters, Faber & Faber, 1998, trad. mia.
2 – Sylvia Plath, Diari, Adelphi, 1998, p. 43.
3 – Sylvia Plath, La campana di vetro, Mondadori, 1979.
4 – Sylvia Plath, The Other, in Tutte le poesie, Mondadori, 2019, trad. mia.
5 – Ted Hughes, Dreamers in Birthday Letters, Faber & Faber, 1998, trad. mia.
6 – Sylvia Plath, The Rival, in Tutte le poesie, Mondadori, 2019, trad. mia.
7 – Sylvia Plath, Two sisters of Persephone, in Tutte le poesie, Mondadori, 2019, trad. di A. Ravano.
8 – Sylvia Plath, Inseguimento, in Tutte le poesie, Mondadori, 2019, trad. di A. Ravano.
*
BIBLIOGRAFIA ULTERIORE
Linda Wagner-Martin, Sylvia Plath, Castelvecchi, 2016, trad. di P. Pavesi.
Leonetta Bentivoglio, Sylvia Plath. Il lamento della regina, Clichy, 2017.
Dave Haslam, La mia seconda casa. Sylvia Plath a Parigi, 2022, trad. di D. Marcatajo.
Sylvia Plath, Quanto lontano siamo giunti. Lettere alla madre, Guanda, 2015, a cura di M. Fabiani.
* * *
Valentina Furlotti è nata a Parma nel novembre del 1993. È laureata in Filosofia e si è specializzata come docente di sostegno. Insegna in un istituto agrario. “Fosforescenze” (Interno Libri, 2023), la sua prima raccolta poetica, ha vinto la XXXVI edizione del Premio Camaiore Proposta Vittorio Grotti, è risultata finalista al Premio Prato e ha ricevuto una menzione speciale al Premio Lorenzo Montano. Suoi testi compaiono su vari quotidiani, lit-blog e antologie, tra cui “L’anello critico 2023” (Capire Edizioni, 2024), il nono “Almanacco dei poeti e della poesia contemporanea” (Raffaelli, 2022) e “Secolo donna 2024” (Macabor, 2024). È caporedattrice di Atelier e condirettrice artistica di Vianino in poesia. Collabora con Interno Poesia Blog.
* * *
© Fotografia di dominio pubblico. Fonte: Wikimedia Commons.