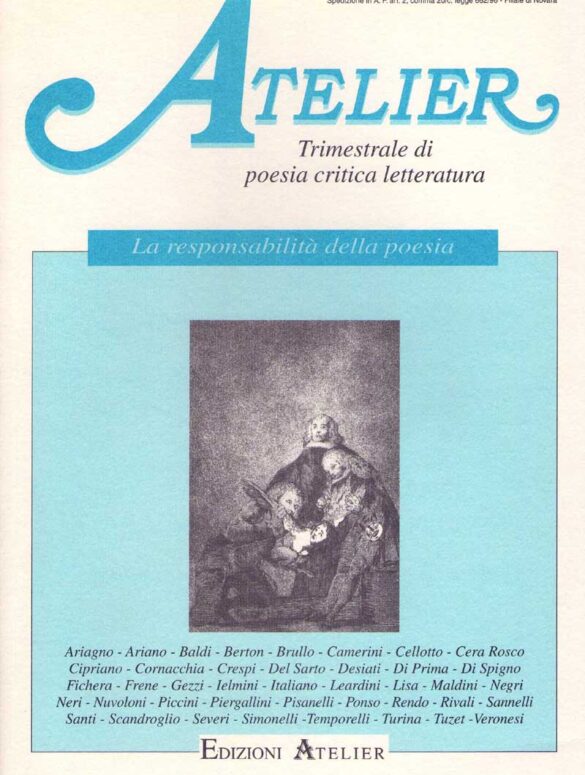Dove parole non sono pronunciate
Costruiremo con nuovo linguaggio
C’è un lavoro comune
T. S. Eliot
in se stessi perduti prima di ogni salvezza
G. Giudici
Ci siamo chiesti che senso avesse interrogarsi sulla poesia in tempi così drammatici.
Ma la domanda, evidentemente provocatoria e strumentale del convegno (“di che cosa siamo poeti?”) è forse risuonata con maggiore potenza pure in chi da sempre ha messo in risalto il nervo dolente di un fare poetico non risolvibile unicamente all’interno della sfera ludica, ma sempre sollecitato dalle ombre della storia, per quanto filtrate entro il proprio infimo angolo ottico.
Dunque qual è la responsabilità della poesia (nel duplice valore del genitivo) oggi?
Ogni tempo è drammatico e anche i frangenti della storia in cui risulta meno appariscente il germe agonico dell’umanità, persiste un movimento profondo e potente che fa appello alle coscienze. I recenti avvenimenti, purtroppo, lo ribadiscono. (Si è detto: la storia è cambiata. Ma non era già in avanscoperta da tempo, rispetto al nostro pensiero, alla nostra immaginazione?)
Così, se non c’è un tempo fuori da una visione storica ingenua che possa sentirsi privilegiato, il presente è sempre propizio per riscoprire il senso del nostro passaggio, e per lavorare affinché la vita corrisponda alla giusta direzione.
Oggi il poeta cerca una musica all’interno di un brusio di sottofondo tremendo e banale, squallido e stupefacente. Forse riesce a distinguere nel caos – mentre il massaggio mediatico continua a trasformare la realtà in un film già visto e insignificante -, qualche voce: «Il nemico è dentro di noi», «Siamo tutti responsabili di quello che succede in qualunque parte del mondo», «Parliamo sempre dell’Altro, ma lo conosciamo realmente?», «In una società così complessa e ipertecnologica, la variabile impazzita che fa saltare il sistema è la più semplice: l’uomo», «È vero solo ciò che vediamo in televisione o ci sono altre guerre, altre verità, altri come noi?». Banalità tremende, snocciolate nel ritmo devitalizzante dei dibattiti televisivi, nelle lacrime spettacolari che non sappiamo più ascoltare quando sono sorde e reali, intorno a noi, eppure problemi che tutti gli uomini devono porsi.
Ma la poesia, memoria dell’umano, ha smesso di vegliare su tutto ciò (parlando magari d’altro, ma in modo non stonato rispetto alla musica dell’epoca)?
Per porsi tale domanda, ci vuole una buona dose di coraggio – forse persino di arroganza e di ingenuità. Chi può dirsi poeta? Chi può pretendere di portare avanti la responsabilità della poesia, come se altri non lo stessero facendo?
Un tema del genere potevano affrontarlo solo dei giovani ribaldi e intelligenti che non hanno nulla da difendere – perché non hanno ancora un posto definito e forse nemmeno un’identità chiara a sé stessi -, perché non hanno nulla da pretendere – doppiati dai canzonettari, derisi persino da chi “fa cultura” -, perché sono ormai perfettamente liberi di amare qualcosa in modo gratuito – quale risibile potere può garantire la poesia? -, perché non vogliono imporre nulla alla poesia, ma imparare a riconoscerla e a darle voce. Una simile questione si può risolvere solo in modo ispirato: altrimenti si ripetono le solite, solide verità alle quali siamo stati educati. Abbiamo tutti robusti anticorpi contro ogni forma di eccesso: questa modestia può essere la nostra forza e il nostro limite.
A dirla tutta, ci è sembrato persino urgente porre tale domanda ai giovani trentenni, perché il sistema sta già mettendo in moto delle strategie sottili per assorbire il nuovo. C’è un certo interesse editoriale per i giovani: sono uscite persino tre antologie (ma come sono diverse, anche se pochi riescono a sentirlo) per segnalarli. C’è chi fa scuola di poesia sui rotocalchi. C’è chi, da buon accademico, la fa altrove. Tutte cose giuste e sensate, per carità, che rendono onore a chi si adopera per la poesia; impegni persino utili, a patto però di saperli usare, di non farsi usare da essi.
Ne abbiamo contattati più di cento. Abbiamo fatto rimbalzare su Internet un dibattito d’apertura, prima di arrivare a darci un testo per discutere. Ne abbiamo incontrati di persona molti, raccogliendo indicazioni e suggestioni importanti. E, finalmente, abbiamo condiviso due giorni intensi, di dibattito e di festa, di conversazioni in osteria a notte inoltrata e di scambi di letture sotto un cielo troppo radioso per essere credibile. Ci siamo addirittura sorpresi per la capacità di discutere con gusto, in modo disinibito e leale, ricchi delle nostre diversità di vedute.
Queste pagine sono un primo resoconto di tutto questo; ma gli interventi che raccogliamo non sono sufficienti per raccontare anche quel seme di amicizia che ci siamo trovati fra le mani né, soprattutto, possono rendere giustizia alla consapevolezza che è maturata, in quei frangenti, di compiere un atto importante ma non decisivo, propedeutico semmai al lavoro vero, alla scrittura. Il convegno non a caso si è concluso, in verità aprendosi, con una lettura di testi e una chiacchierata spontanea intorno ad essi.
Da molti anni «Atelier» s’impegna a offrire un’officina per coloro che mettono mano alla poesia con la stessa tensione con cui ciascuno, oggi come ieri, è chiamato a farsi responsabile del mondo, a partire dai propri spazi privati, dai piccoli doveri quotidiani da portare avanti – anche e soprattutto nella gioia, nella pienezza della vita che a tratti ci trascina e sconvolge.
Se nessuno ha mai alzato bandiere ideologiche o poetiche, è pur vero che chi scrive è certo della necessità di prendere posizione di fronte allo snaturamento perverso che molte forze, anche e soprattutto all’interno della cultura, stanno cercando di imporre alla poesia, perché resti potente e inquieto monito contro ogni addomesticamento dell’intelligenza umana, senza pretendere, naturalmente, di imporle un tema preconfezionato o dei modi precostituiti.
Per questo, ora, vogliamo che il lavoro autonomo di questi giovani provi a interagire all’interno di un’opera comune che travalica, a un certo punto, lo stesso orizzonte generazione, per cercare risposte, coesioni, dissensi anche in verticale: arrivando a tracciare solchi profondi fra le tradizioni, e far emergere qualcosa di nuovo, di veramente contemporaneo – cioè capace di parlare del nostro tempo così complesso, di aprire molte domande e suscitare qualche risposta.
Il nuovo, in quanto tale, non è inizialmente riconoscibile, ma la sensazione è che questi giovani abbiano, complessivamente, precise convinzioni: rimossa l’Avanguardia, cercano una poesia semplice ma non semplicistica, sono tesi verso il mondo che li circonda ma non hanno l’ansia di carpirne il consenso. Parlano di cose concrete, partendo dalla loro esperienza, ma puntano alla visione. Hanno il coraggio di osare, di esigere. Non fanno calcoli sulla loro pelle, sanno spendersi con generosità. Sono, insomma, responsabili: non distinguono fra pubblico e privato in quello che fanno.
Sono talmente responsabili, anzi, da non avere voglia di lanciarsi in facili proclami: sentono il Novecento alle spalle, sanno di essere all’inizio di qualcosa, ma hanno la pazienza di continuare a interrogare il passato, di fare molto silenzio, per prepararsi alla poesia.
Ecco, forse la provocazione del convegno voleva giungere proprio a questo: fomentare l’ascolto. Forse il valore di una poesia (e dunque il merito di un poeta) non ha origine in sé stessa. Una poesia in qualche modo non è autosufficiente, per quanto autonoma: la sua origine ci porta fuori di essa, il suo completamento è altrove.
Dunque scrivere non è un vizio borghese, un trastullo per civiltà decadenti, uno scialo di parole ed emozioni capaci di reggere il palco e rimbalzare sulle labbra degli adolescenti. È, semmai, la voce disinibita e solitaria che sa far vedere che il sovrano è nudo, che non c’è potere da riverire perché nulla è più potente della parola che pensa il mondo, che si pensa nel mondo: inerme come un seme.
Per questo la gioia del confronto, in questi giovani, ha messo radici in un silenzio grande, che porta in sé anche il dolore di chi sa di dover mettere a disposizione il presente e gli anni che verranno non a un’idea di carriera letteraria, ma al lavorìo dei giorni, all’ardore attutito del vivere.
Marco Merlin