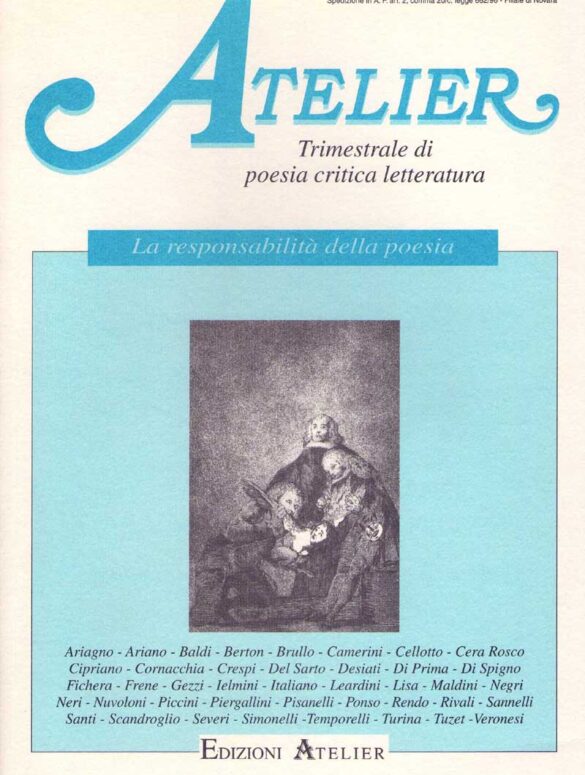Intendo partire da un dato linguistico, meglio, da una pulizia linguistica, necessaria ad evitarmi deviazioni rispetto al tema del convegno. Mi richiamo l’etimologia della parola “responsabilità”, che ha la sua origine nella parola responsum. Essa conservava nel Medioevo il senso primitivo, religioso e giuridico del verbo re-spondere, cioè di “impegnarsi (spondere) di nuovo”, “rispondere ad un impegno preso” e, quindi, in senso più ampio, “rispondere ad una domanda”. È un assunto linguistico questo, ma mi apre una prospettiva nuova, della quale confesso d’esser stato ignaro o, comunque, non cosciente, quella, cioè, di considerare “la poesia come risposta”. Intendo dire, l’accezione che si ha della poesia non è quella della domanda, della interrogazione a volte disperata del poeta? Non è il poeta, in particolare nell’accezione comune presso il lettore, colui che pone sé e il mondo in questione, che pone “la” questione stessa dell’esistenza?
La focalizzazione linguistica con cui ho aperto la mia riflessione mi permette allora di dar completamento all’idea di ciò che la poesia debba, appunto responsabilmente, fare. La poesia è, senza dubbio, interrogazione della vita nelle sue manifestazioni, ma deve, vuole anche dare le risposte che tale interrogazione pone. E ciò, e mi sia permesso l’impaccio linguistico, implica una maggior responsabilità, appunto, da parte del poeta e della poesia stessa. Il compito, l’impegno è, pertanto, duplice: sollevare le questioni (o, più semplicemente, farsene interprete ed eco) e cercare, sforzarsi di dare delle risposte.
Mi riesce arduo e pretenzioso supporre di conoscere quali attese e domande animino gli uomini e le donne del nostro tempo e penso che sia campo di pertinenza delle scienze sociali. Per altro, un’interpretazione dei bisogni del proprio tempo è imprescindibile per il poeta. Trovo del tutto sterile l’idea di pensare a destinatari del futuro, quando non c’è lettura nel presente. La poesia può, deve ritagliarsi il proprio ambito di conoscenza. La strada è quella di investigare il proprio tempo sulla scorta della propria esperienza, del vissuto individuale del poeta, che, come riferito in precedenza, cerca, in buona fede, di farsi interprete di un più ampio sentimento. Posso, appunto come uomo e poeta, tentare di far luce su questioni che percepisco come urgenti e da qui, forse presuntuosamente, cercare di allargare gli orizzonti e generalizzare, anche a costo di sbagliare.
Posso dire con certezza che l’urgenza più viva è di dare chiarezza alla vita: far chiarezza, portare a galla certi aggrovigliamenti e collocarli in un contesto storico che è il presente. Si delineano due piani di indagine per le risposte della poesia: uno che definirei, a modo esemplificativo, interiore, profondo, ontologico; l’altro esterno, derivante dall’incontro del mio essere uomo con gli spigoli della storia, del mondo.
Mi rendo conto di essere entrato a piè pari in una questione sollevata dalla traccia del convegno, il problema dell’ispirazione poetica. L’ispirazione, l’invenzione, il ritrovamento di tracce di senso, questa è allora la prima forma di risposta alla duplice domanda che origina dall’interno e dall’esterno. Da un punto di vista interiore, le questioni che richiedono una risposta non sono cambiate, sono connaturate al nostro essere uomini e donne, sono le domande fondamentali dell’esistenza.
E allora che cosa cambia, che cosa fa scrivere ancora poesia, che cosa sollecita la nostra risposta, la nostra “responsabilità”? È la storia che cambia, il tempo in cui queste domande si vengono a collocare. È la realtà che ci circonda, che modella queste domande, dà loro un corpo, se ne appropria, le caratterizza. Quindi, e venendo al punto, le domande interiori, cui il poeta deve dare responsum, sono ora proprietà del nostro tempo, gli appartengono come noi gli apparteniamo.
Che mondo, che tempo, che storia sono allora questi che ci circondano? Ancora, il rischio è quello di fare della sociologia, della storiografia, della filosofia, della politologia. Trovo però che l’aggettivo “complesso” sia a suo modo riassuntivo e significativo, in grado di definire il nostro tempo, e che sia termine chiaro in modo ampio, perché acquisito nel linguaggio comune. Il nostro è un mondo complesso, si dice, che ha subito furiose accelerazioni nel breve, come mai prima nella storia, e continua a subirne, con un continuo “sradicamento” dell’uomo rispetto al passato, perché il passato, anche quando non è lontano, è lontanissimo per caratteristiche dal presente. Viceversa, il futuro appare assai incerto, volubile, immerso in prospettive apocalittiche e altre eccessivamente positive. In mezzo il presente, schiacciato, confuso, rappreso, complesso, talora persino inestricabile. Ma è il presente in cui sono incarnato, come uomo, anzitutto, e come poeta di conseguenza. È il mio presente, che disegna la mia umanità, è il posto nel quale voglio fare la mia storia, la storia.
Non mi interessa, non deve interessarmi stabilire se questo tempo sia più o meno difficile, semplice, duro, vivibile di quanto non fosse nel passato o di quanto sarà nel futuro: so solo che è difficile e complesso, complicato per me qui e ora e perciò avverto il bisogno di sbrogliare qualche matassa, appunto di fare chiarezza. Insomma, di fronte a questa complessità e nell’insorgere delle domande esistenziali connaturate al mio essere creatura umana, sento la necessità che, dentro e fuori di me, sia dato ordine, che siano costituiti i punti fermi che mi facciano essere uomo nel pieno delle mie possibilità.
La mia premessa “etimologica”, insomma, si è ora volta in una necessità “etica”, un ritorno, insomma, su strade linguistiche, all’alveo naturalmente accettato della parola “responsabilità”, che è intesa appunto in senso etico nell’uso comune. È la responsabilità delle scelte che compiamo nella nostra vita di uomini e donne, nella nostra vita di poeti. Ed ogni scelta che compiamo, come uomini e come poeti, si sostanzia nel nostro essere qui e ora.
Perciò, e venendo ad un’altra delle questioni sollevate dalla traccia del convegno, finisce per sembrarmi sterile stabilire se siamo fuori o dentro il Novecento. Siamo nel nostro tempo, chiamiamolo post Novecento o nuovo millennio, chiamiamolo come vogliamo, lasciamo ai critici il compito di trovare le categorie giuste: io, come poeta, lo chiamo «il mio tempo» e credo sia già una prospettiva storica non trascurabile, quella di sapersi in qualche modo collocare. Non intendo scappare e dire che non lo amo, il mio tempo e nemmeno dichiararmi in una percentuale di vita bassa, in un nido aristocratico di ironia o in una cantina chiusa che sa unicamente di attesa o in un iperuranio linguistico puro, assoluto. Se questo era il Novecento, bene, allora sono fuori del Novecento, a piè pari e, quindi, poeta del mio tempo, che risponde alla esigenza di chiarezza, di ordine che viene dalla complessità e dallo sradicamento del mio tempo.
Ma, come detto, la responsabilità della poesia non è (almeno in prima istanza) politica o sociologica o storiografica (benché credo con tali saperi debba seriamente, “responsabilmente” confrontarsi): è anzitutto artistica, estetica, linguistica.
A questo punto giungo a conclusione del breve percorso tratteggiato, indicando certe convinzioni che ho maturato (e cerco, mi sforzo di perseguire) circa le scelte linguistiche e formali, estetiche.
A scanso d’equivoci, sottolineo subito come la necessità di chiarezza, di ordine, di una forma che plasmi e in qualche modo non faccia sfuggire il reale, ecco tutto questo non implica un ritorno al formalismo poetico o, almeno, non ad un formalismo che voglia porsi come “la” risposta, appunto, a questa esigenza che io avverto, di chiarezza ed ordine. Piuttosto ritengo che, se complessa e stratificata è la materia, la lingua che può interpretare l’esigenza di chiarezza deve essere lingua aperta a ricevere la complessità, non chiusa o criptica, una lingua capace di appianare, di correr via fluente, narrativa, in grado di raccontare e sciogliere gli enigmi, le domande, una lingua che lentamente faccia emergere le risposte, una lingua che parli alla storia raccontando delle storie, le storie degli uomini, una lingua aperta ai molteplici linguaggi della contemporaneità, ma non mimetica rispetto alla realtà ed alla molteplicità linguistica stessa. Se la poesia registrasse la realtà, se si confondesse con altri generi di espressione, non assolverebbe alla propria responsabilità, appunto, al proprio compito di dare risposte. Sarebbe un’eco sterile, vuota e finirebbe per non essere di alcuna “utilità” – lasciate che mi serva di questo termine che mi urge come necessità, termine che sento particolarmente caro, al momento della scrittura. Ciò che immagino e che intendo perseguire anche nei miei testi è “una lingua”, “una forma” che definirei “germinativa”, che non faccia del bricolage o della casuale giustapposizione sperando che da essa si generi senso (ancora, in questo senso mi sento lontanissimo da certe esperienze d’Avanguardia e Neoavanguardia novecentesca), ma che attorno ad un’idea centrale del testo, ad una sua costruzione, ad un progetto fermo, sappia restare aperta alle sollecitazioni e faccia germinare da esse ulteriori domande e si sforzi di trovare, appunto, altrettante “risposte” (non un’opera aperta, però, infinitamente aperta ed enciclopedica). Ripeto: un’opera che abbia un centro ben visibile, un nucleo, attorno al quale si vadano germinando nuovi nuclei, una poesia che germina le risposte, che le nutre e ne fa dono.
Riccardo Ielmini